Cartellina documenti Assemblea nazionale Roma 2025


- Programma dell'Assemblea
- Documento di Roma "Un'Altra Idea di Mondo".
- Proposta di Statuto Nazionale.
- Candidatura per il Consiglio Direttivo
- Documento di mandato
- Proposta di Collegio Nazionale dei Garanti
- Proposta di Organo di Controllo
- Proposta di Commissione Statuto
- Proposta di Commissione Elettorale
- Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee
Mentre scrivo già so che questa relazione sarà difficile. Da giorni rimuginavo su cosa dire, quanto dire e come dirlo!
Aprivo il foglio word.
Mi scoraggiavo.
Richiudevo il foglio word.
Qualcuno a cui ho confessato questo “blocco” mi ha detto: tanto alla fine arriverai lì e ti farai guidare dall’emozione, come se questo potesse tranquillizzarmi! È proprio quello che vorrei evitare invece! 😊
Certo se ripenso alla me di quattro anni fa e ai miei compagni di strada. ROBERTA, FEDERICO, GIACOMO, RAOUL, provo una certa tenerezza. E chi aveva idea di cosa ci aspettava? Certamente non noi: e non li guardo negli occhi adesso ma sono certa che un po’ sorridono e un po’ scuotono la testa a ripensarci.
Non posso non ricordare in primis il ritrovarci nel dopo-covid e nel pieno della riforma del terzo settore: due questioni, ovviamente di peso molto diverso, ma ognuna a suo modo, epocali. Il dopo pandemia con la disabitudine ad incontrarsi e alla dimensione collettiva. E la riforma del terzo settore che pronti via ha scandito almeno il primo anno di lavoro con i passaggi formali, tecnici ma anche culturali ancora in corso.
Noi cinque avevamo tante idee e qualche preoccupazione ma certo non avevamo chiaro l’intensità dell’avventura -terrific!- che ci aspettava.
Se guardo a ciò che ci eravamo ripromessi di fare, rilevo onestamente che non tutto, ma molto, è stato davvero fatto.
Volevamo ripartire dai contenuti e dalla rete.
E il primo contenuto da cui ripartire era -proprio nel post covid- il valore della dimensione associazionistica, di tutto il terzo settore e il volontariato stesso, di quanto dovessero essere rafforzati convintamente in quanto luoghi e modi, attuali e futuribili, di elaborazione e pratica della solidarietà, della coesione, dell’inclusività. Avevamo e abbiamo la convinzione che l’Italia sia un luogo migliore grazie a tanti esseri umani che si dedicano al bene della collettività, lasciando indietro gli interessi individuali e specifici, ma prendendosi cura della cosa/casa comune, degli spazi pubblici, del prossimo e dei prossimi, vicini o lontani che siano. Avevamo e abbiamo la convinzione che la partecipazione alla vita civile, l’espressione di opinioni, le prese di posizione, la manifestazione del dissenso, siano linfa vitale della democrazia e di una società sana e plurale.
Certamente siamo tornati sui territori: li abbiamo camminati in lungo e in largo, abbiamo incontrato tante ma tante piccole o minuscole esperienze preziosissime che si potrebbe rischiare di perdere nel grande mosaico che compone Slow Food, ma che invece risultano esserne i dettagli più squisiti, più complessi, più unici. Abbiamo ascoltato la nostra rete e ci abbiamo parlato, abbiamo discusso anche animatamente e ci siamo abbracciati, abbiamo lavorato insieme, presidiando i territori, coinvolgendo cuochi alleati, avviando nuovi orti, mercati e Presìdi, scoprendo osterie e storie, abbiamo insomma provato sempre e comunque a rendere più bello quel pezzo di mondo a cui abbiamo accesso, sentendoci, in ultima analisi, dalla stessa parte.
E affinché questa stessa parte fosse sempre più ampia e variegata e di valore, ci siamo convinti di quanto fosse importante uscire dalla competizione sistematica ed entrare nella logica della cooperazione: e quindi abbiamo avviato tanti dialoghi e confronti, con organizzazioni, enti, altre associazioni, molti di loro sono oggi qui con noi e sanno che parlo di loro! Con alcuni abbiamo percorso tratti di strada e poi ci siamo separati, e magari ci incontreremo ancora più avanti, con altri abbiamo generato alleanze durature o lo faremo, ma di certo mai ci siamo sottratti al confronto. Convinti che esercitare la comprensione e il dialogo, anche sacrificando un po’ delle certezze su cui si stampella l’ego, non possa che farci bene. E allora penso alle tantissime intese, alle mobilitazioni, al grande lavoro con le istituzioni nazionali e locali, alle interlocuzioni che abbiamo avuto sia formali che informali a tutti i livelli. E che non ci hanno indebolito: ci hanno resi più forti. Diversi, ma vicini nei temi comuni. Con l’obiettivo di incontrarci su quel che ci unisce invece che concentrarci su quel che ci divide. Considerando la differenza una ricchezza invece che una criticità. Praticando concretamente ed esercitandoci ad una cultura di pace: oggi quanto mai urgente.
In cartellina trovate una raccolta di dati che si focalizza su alcuni ambiti di azione e che mostra una generale crescita innegabile in questi quattro anni e ringrazio le colleghe che mi hanno aiutato a raccoglierli. Ci sono poi i bilanci sociali che ci hanno permesso di monitorare ciò che abbiamo fatto e come. E sebbene questo non basti a raccontare tutto, nemmeno lontanamente, serve comunque ad aver contezza di una tendenza.
…Ma non volevo presentare slide, volevo raccontare con libertà.
Una cultura di pace oggi quanto mai urgente. Si diceva.
Una cultura di pace che oggi mi rendo conto era nel nostro percorso senza chiamarsi così: c’era già nel ripensare il rapporto con gli animali a partire da Cheese 2021; era nella rigenerazione del Terra Madre post Covid, nel 2022, quando dovevamo prima di tutto ridare vita alle relazioni fisiche, quando dovevamo imparare di nuovo a creare “assembramenti”; era nel Coast to Coast di Fish 2023, a evidenziare le connessioni che il mare genera; era nel “Sapore dei prati” di Cheese quello stesso anno: luoghi di pace, dove gli erbivori vivono in base alla loro etologia e quell’erba, e quella naturalità, la si ritrova nel sapore dei prodotti caseari che ci nutrono; la pace con la natura, nel 2024, a cui abbiamo dedicato Terra Madre: anzi “Noi siamo natura”, noi SIAMO natura, essere in guerra con lei significa essere in guerra con noi stessi.
Una cultura di pace è il sottotesto dell’educazione di adulti e bambini al piacere della scoperta, alla consapevolezza delle scelte, alla capacità di critica che è anche capacità creativa, alla bellezza come “motore silenzioso di cambiamento”. Per questo ogni martedì trasmettiamo Food To Action: la formazione riservata ai soci che tratta i nostri temi e li contestualizza. Per questo, nel 2024, i vent’anni della nostra Università li abbiamo celebrati lanciando l’appello per l’educazione alimentare!
Una cultura di pace che ci ha portato sull’Ocean Viking, nel 2022, con i sei quintali di riso “Gigante di Vercelli”, nostro presidio: a metterci la faccia e il corpo, perché nella nostra dichiarazione di Chengdu abbiamo sancito che “nostra casa è il mondo intero” e quindi ci interessa e vogliamo aver cura di chi attraversa il mare e l’inferno per trovare una speranza di vita in Europa. E quindi ci è parso normale collaborare al progetto “Youth And Food” per i minori non accompagnati che attraverso il cibo hanno imparato dei mestieri e hanno costruito una vita possibile. Una cultura di pace che ci ha portato ad esprimerci sulle crisi belliche in corso, dal conflitto russo-ucraino, alla guerra in Sudan, allo sterminio in Palestina. E’ una cultura di pace quella che ci guida nella costruzione di progetti di viaggio che tutelano la biodiversità e le comunità; che ci fa credere in una mensa che sia il convivio per eccellenza di tutte e tutti, e in particolare una mensa scolastica che sia un diritto e non un servizio; che ci permette di vedere il Mediterraneo come un mare che unisce prima di dividere, un luogo di biodiversità e di ecosistemi marini e costieri da tutelare perché in fondo “veniamo tutti dal mare”; che ci fa immaginare le città dialogare con le campagne in una logica di collaborazione e non “di servizio” tramite oculate e lungimiranti “politiche del cibo”. Una cultura di pace che ci permette di usare il cibo per creare ponti.
Una cultura di pace che cerca di dar voce a chi ne ha meno: le donne, i giovani. In questi anni cercati, ascoltati, visti: penso alle “Dieci donne che salvano la terra” e penso all’incontro di Roma “Cibo Clima Bellezza futura”. Perché abbiamo bisogno delle vostre voci, dei vostri occhi, dei vostri pensieri.
Una cultura di pace sottesa in ogni appello, documento di posizione, mobilitazione, campagna, di questi quattro anni bellissimi e complessi in cui l’attualità ci ha messo di fronte a questioni che non ci hanno mai annichilito, ci hanno anzi permesso di interrogarci e crescere:
-Abbiamo voluto sostenere una prospettiva di valore per le “terre alte”: luoghi fatti di gente e saperi, luoghi di spazi e silenzi, luoghi dove all’abbandono si risponde coi ritorni, dove alle criticità si reagisce con creatività, dove all’ineluttabile si sostituisce la resilienza. Abbiamo lavorato sui prati stabili, ricchi di biodiversità e necessari ad “un’altra idea di” allevamento, estensivo, rispettoso dell’etologia animale, che giova alla fertilità del suolo e che genera prodotti unici, dal punto di vista nutrizionale e organolettico, che contribuisce a disegnare e tutelare il paesaggio non come “fondale” di servizio al turismo, ma come testimonianza autentica di vitalità dei territori. E insieme a questo compongono una proposta complessiva per le terre alte la vitalissima rete della castanicoltura, un’oculata lungimirante e sensata gestione dei boschi, una rinnovata cultura pastorale che individua nella pastorizia un mestiere moderno e qualificato.
-Abbiamo, come facciamo da trent’anni, supportato i prodotti caseari a “latte crudo”: per questo nasceva Cheese! E abbiamo fatto la nostra parte anche in questa ultima fase così difficile, per difenderne il valore, perché le competenze ad esso legate non fossero scordate o dismesse, perché mentre si discute come mettere in sicurezza l’innegabile sacralità della salute e della vita, non si dimentichi un mondo caseario secolare che rende la biodiversità artigianale italiana preziosa e rara, se non unica. E in ultima analisi, non si dimentichi la sacralità di esistenze fondate proprio su quell’artigianalità.
-Abbiamo promosso anche fattivamente la formazione degli operatori perché riteniamo che sia necessario qualificare il lavoro del contadino, del pastore, dell’oste, del pescatore, ecc. riconoscendo ed implementandone le competenze, attualizzando l’approccio e connotando queste figure come “avanguardia”, come mestieri per il futuro, per i giovani, se si crede, e noi ci crediamo, nel diritto di tutti ad un futuro di pace e prosperità e al cibo buono pulito e giusto che lo nutre. Perché non esiste futuro senza un sistema agricolo e alimentare equo: verso i lavoratori, verso gli esseri umani tutti, verso gli animali, verso l’ambiente, verso le nuove generazioni.
-Abbiamo proposto l’agroecologia come strada possibile per quel “One Welfare” che dovrebbe essere obiettivo comune. L’agroecologia che propone una visione integrata del sistema agricolo, basata sull’armonia tra attività umane e ambiente, sul rispetto delle risorse naturali, sulla cura del bene comune. Mette al centro le comunità, la biodiversità, la fertilità del suolo, il rispetto per gli animali, la salute del pianeta e di tutto il vivente. Questo per forza ha significato coerentemente mettere in discussione un modello agricolo che ha bisogno del glifosato, di input energetici importanti, di pesticidi e fertilizzanti di sintesi i cui residui si rintracciano nel suolo anche dopo decenni, un modello agricolo imperniato sull’energia fossile che oggi non è innovazione: è un modello gravemente obsoleto che non può essere accettato come proposta per l’oggi, tantomeno per il domani!
-Abbiamo voluto riflettere, accogliendo la complessità, sulla carne coltivata in laboratorio che inevitabilmente incrementa la distanza tra noi e il cibo, sulle nuove biotecnologie che se vengono chiamate “nuovi ogm” creano scompiglio e che sono quindi state ribattezzate TEA o NGT, sull’innovazione tecnologica che ci serve solo se inclusiva, sulle energie rinnovabili che devono poterci avvicinare alla transizione, e non essere strumento di speculazione sull’agricoltura.
Una cultura di pace.
Che passa dal cibo.
Una cultura che nell’attualità globale di oggi ci fa aborrire l’idea del cibo come strumento di guerra e di morte invece che di dialogo e di pace.
Fiducia e Speranza dicevamo quattro anni fa: la concezione di bellezza di Goethe. Quanto ne abbiamo bisogno oggi?
Fiducia. Speranza. Bellezza. Pace.
Perché saremmo perduti se accettassimo che l’impunità possa diventare una strategia.
Che lo sterminio possa essere strumento di governo.
Che la compassione possa essere considerata debolezza.
Ma oggi non siamo perduti. Infatti, al solo pensiero la mente vacilla, il cuore perde battiti. Menomale: sono viva, so sentire il dolore altrui, tutto funziona. Non siamo ancora perduti.
Ma siccome oggi noi non siamo ancora perduti, rivendichiamo la NECESSITÀ E IL DIRITTO di immaginare INSIEME un’altra idea di mondo: qui ed ora, e di lavorare per costruirlo pezzo per pezzo, fin dove riusciamo ad arrivare col nostro raggio d’azione che moltiplicato per una moltitudine diventa grande come il Pianeta tutto.
Un’altra idea di mondo: grande e bella come il mondo.
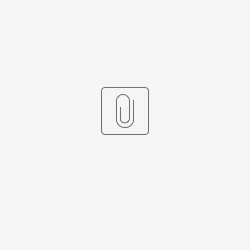 Report 21-24 Nappini Assemblea Roma 2025.pdf
Report 21-24 Nappini Assemblea Roma 2025.pdf
Buongiorno a tutte e tutti, grazie di essere qui….
Quattro anni fa abbiamo avviato un progetto politico ambizioso per ri-portare al centro i contenuti e i valori fondanti di Slow Food. Eravamo convinti che le connessioni attivate dal cibo fossero la chiave per cambiare il mondo. Oggi, siamo ancora qui con la stessa convinzione e lo stesso desiderio di costruire un’alternativa concreta.
Seppure in questi anni il contesto sia mutato rapidamente il modello dominante di produzione del cibo continua ad avere un impatto devastante sulla salute dell’ambiente e delle persone. Nel frattempo, il 2024 è stato l’anno più caldo del secolo: per la prima volta abbiamo superato il limite di 1,5°C di aumento della temperatura media globale rispetto al periodo preindustriale. A livello planetario, i cambiamenti climatici stanno alterando radicalmente il ciclo idrologico e questi fenomeni non sono lontani da noi: eventi estremi, ondate di calore, siccità, alluvioni, tempeste improvvise colpiscono anche il nostro Paese, rendendo sempre più vulnerabili proprio quei territori a cui Slow Food ha dedicato da sempre grande attenzione: le Terre Alte.
I nostri territori e le comunità rurali che vi abitano. La parte più autentica, creativa e vera dell’Italia. Ma anche la più fragile. Quella che per secoli ha garantito beni essenziali — acqua, aria, cibo — a chi abitava nelle valli e nelle città. Territori svuotati, marginalizzati da uno sviluppo economico che ha privilegiato i centri urbani e le coste, lasciandoli indietro, considerandoli marginali.
Oggi, dopo decenni di abbandono ingiustificato, le Terre Alte stanno tornando a vivere grazie a relazioni nuove frutto della capacità di chi ha scelto di restare e di chi ha deciso di tornare o di iniziare una nuova vita legata alla terra e alla natura. Nascono così le comunità del futuro, veri e propri esperimenti sociali, che costruiscono convivenze inedite e sostenibili. Realtà che combinano le attività umane con la tutela ambientale, come accade nelle pratiche di ri-naturalizzazione quando un bosco viene reso più resiliente da pratiche boschive sostenibili, o un fiume tombato reso libero dal cemento e meno pericoloso.
Una grande opportunità, che Slow Food negli anni ha saputo cogliere, contribuendo alla tutela di un immenso patrimonio di biodiversità naturale fatto di boschi, foreste, fiumi e biodiversità agroalimentare ma anche un patrimonio culturale e sociale, fatto di saperi (tradizioni, folklore, dialetti) competenze e capacità (sempre più rare) come quelle necessarie per gestire bene un pascolo o un castagneto o ripristinare un paesaggio terrazzato (come avviene nelle colline vitate del Presidio del Carema o dello Sciacchetrà nel Parco delle Cinque Terre).
Non si tratta solo di racconti, ma concreti progetti di rigenerazione ambientale, delle comunità, del benessere: il (1) progetto dei prati stabili e i pascoli lanciato nello scorso Terra Madre, la (2) rigenerazione dei boschi di castagno attraverso pratiche tradizionali piuttosto che (3) l’agricoltura e i presìdi di montagna (mieli e formaggi), (4) la campagna di sensibilizzazione per promuovere un consumo consapevole di carne e il benessere animale, l’allevamento estensivo e l’evento “Distinti salumi”.
Esperienze vive, cariche di umanità e di significato politico, che abbiamo imparato a conoscere girando l’Italia in lungo e in largo in questi quattro anni, dove le nostre comunità del cibo operano ogni giorno: intorno ad un prodotto dell’arca, un nuovo presidio, quando si riaccende un forno (come qualche settimana fa a Mugnanesi sul Lago Trasimeno).
Progetti di comunità che sono un vero antidoto al modello attuale della competizione, dell’individualismo, della solitudine diffusa delle città a cui rispondono con la cooperazione, la condivisione, la solidarietà e il senso civico e il loro senso del limite per l’uso delle risorse naturali innato nelle comunità rurali.
Piccoli esperimenti “potentissimi” per l’idea di mondo che vogliamo e che (tutti noi) abbiamo il dovere di sostenere e mettere in rete perché siano esperienze virali.
Anche una straordinaria palestra associativa che in questi anni ha permesso di calare sul territorio gli obiettivi politici nazionali di Slow Food, grazie alla partecipazione determinante delle reti regionali. Una costruzione corale di nuova dignità per le Terre Alte: per chi le abita, per le comunità del futuro e per i mestieri della montagna. A cominciare dal mestiere del pastore e dal ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità e del paesaggio.
La Scuola di Pastorizia di Calascio in Abruzzo è un esempio in questa direzione: una scuola per giovani generazioni di pastori e allevatori che possano garantire il ricambio generazionale, trasmettere saperi e tecniche caseari secolari, valorizzare razze autoctone, produzioni tipiche con un approccio integrato, sostenibile. Che guardi al futuro, che alimenti fiducia nei giovani e possano trovare un “buon motivo” per restare e vivere dignitosamente. Perché è un loro diritto!
Sarà importante intensificare l’ampia riflessione avviata nell’ecosistema vino di Slow Food, dall’evento di Bologna (SWFair, la SWCoalition che unisce tutti i protagonisti della filiera fino alle attività della Banca del Vino). Un ambito che, accanto alla pastorizia e all’agricoltura, deve diventare sempre più centrale nella strategia sulle Terre Alte, perché la viticoltura rappresenta un altro pilastro fondamentale della cultura e dell’economia di questi territori.
Questa la strategia per riportare le Terre Alte al centro del dibattito politico sul futuro del nostro Paese per cui stiamo costruendo alleanze solide con altre associazioni, istituzioni regionali e le comunità locali partendo dal basso per capovolgere la narrazione e invertire la tendenza: da (1) luoghi dell’abbandono a protagonisti della soluzione, da (2) rifugi temporanei o mete del turismo di massa a luoghi privilegiati dell’abitare. (3) Dove mestieri considerati marginali o superati possano diventare opportunità professionali e di vita.
Lo faremo a partire dai prossimi eventi Cheese e Oltreterra, lavorando sui due grandi pilastri del modello di integrazione agrosilvopastorale in cui crediamo: il Presidio dei prati stabili e la Rete Slow Food dei castanicoltori.
Le Terre Alte non sono territori da salvare, ma territori che ci possono salvare. A chi ci vive e a chi vive in città. Perché nemmeno le città possono fare a meno de loro contributo essenziale.
Allora ripartendo dal cibo che ci riconnette alla terra, dalla consapevolezza dei benefici ecosistemici che produce (dalle T.A. alle città) e da un nuovo patto ecologico, che sia anche sociale ed economico tra aree marginalizzate e città — potremo davvero immaginare un futuro diverso. Invece di arrenderci all’idea di uno “spopolamento irreversibile”.
Noi crediamo che il futuro delle Terre Alte, ma anche di questo Paese dipende dal coraggio che avremo. Il coraggio che in questi anni non ci è mai mancato.
Avanti, con umiltà e determinazione.
“Un'altra idea di mondo”, a partire dal cibo, è ancora possibile…..
Grazie!
Ho 4 minuti per presentarmi e per dare un’indicazione politica di quelli che vorranno essere i prossimi 4 anni. Un quadriennio che vedrà la nostra associazione compiere 40 anni… un tema ricorrente quello del 4.
Ebbene, anche l’inizio della mia esperienza a Pollenzo, e quindi in slow food - sì perché l’università delle scienze gastronomiche di Pollenzo è l’università di slow food - anche quell’esperienza, che mi ha letteralmente cambiato la vita, è iniziata all’insegna del 4.
Dopo 4 anni di triennale in economia aziendale - dove capirete che non mi sono trovato troppo a mio agio – sono arrivato Pollenzo per la magistrale, e da lì è stato tutto un crescendo. A chiudere il cerchio, 4 anni fa sono entrato a lavorare nell’ufficio del nostro fondatore Carlo Petrini.
Ci ho pensato bene - e sono convinto - che anche per slow food sia il 4 a fare la differenza. Il 4 per me rappresenta quella locuzione che spesso anche la nostra presidente, Barbara Nappini, aggiunge dopo il nostro motto più famoso: buono (1), pulito (2) e giusto (3) per tutti (4).
Nel dire che slow food è per tutti, infatti, siamo convinti che tutti possano assimilare i nostri messaggi e allo stesso tempo che tutti possano godere degli effetti che derivano da un mondo davvero buono, pulito e giusto. Ma sappiamo che non è così. Sappiamo che non tutti si sentono affini al nostro pensiero. E sappiamo ancora meglio che il mondo, oggi più di 40 anni fa forse, non è sempre buono, pulito e giusto.
Allora cos’è slow food, cosa siamo noi? Cosa possiamo fare, oggi più che mai?
Slow food può e deve essere sempre più una guida.
Guida per consigli gastronomici, certo, ne abbiamo molti a riguardo: osterie, vino, olio, birra…
Ma guida soprattutto verso un nuovo umanesimo che non ponga più l’uomo al centro di tutto ma che veda il fulcro di un futuro migliore nel rapporto che noi possiamo e dobbiamo ricostruire con gli ecosistemi in cui viviamo. Quegli ecosistemi di cui facciamo parte e che, per quanto ci proviamo, non riusciremo mai governare - per fortuna.
Per essere guida dobbiamo anche saper guardare al diverso e saperci affidare a chi ha più esperienza e conoscenza di noi. Per questo, con questo mandato, vorremmo costruire una consulta dei saggi, un momento per il consiglio direttivo - ma non solo - per apprendere, per ampliare i nostri orizzonti e per meglio interpretare il ruolo di guida, in maniera ancora più credibile.
E a proposito di credibilità, ci sono tre aspetti su cui vorrei riflettere con voi.
1 - siamo l’unica associazione al mondo che ha saputo fondare un’università. Non solo questo, un’associazione che ha saputo creare una nuova disciplina accademica: le scienze gastronomiche. Per questo, dobbiamo avere coscienza che Pollenzo, è stato possibile grazie alla credibilità che l’associazione tutta ha saputo raggiungere nel corso degli anni. E per questo dobbiamo sentirlo più nostro.
2 - secondo punto, per essere ancora più credibili noi dobbiamo iniziare a intercettare - a raccogliere - chi è slow food per sua stessa natura ma non sa della nostra esistenza. Recentemente ho conosciuto un giovane produttore siciliano che ha vissuto lo smarrimento, lo sconforto e il rischio di abbandonare la sua professione. Ebbene lui non ci conosceva, ma il solo intercettare della gente che pensa al cibo, all’agricoltura, al futuro, esattamente come l’ha sempre pensato lui - il solo conoscere che c’è una rete che vuole preservare il lavoro eroico come il suo – solo questo gli ha cambiato la vita. E non solo non ha abbandonato la sua terra, ora è tornato a pensare che lui quella vita non la abbandona più.
3 - terzo e ultimo punto, oggi - per essere credibili - dobbiamo saper dialogare con i giovani, con quel mondo che anche io, che ho 30 anni e che, sebbene sia sempre stato vecchio dentro, sono anagraficamente il più giovane di questo gruppo di lavoro, non riesco a comprendere a pieno. Entrare in contatto con i più giovani è un dovere se crediamo davvero in quel mondo buono, pulito e giusto, e se vogliamo per davvero che questi ideali possano accompagnare anche i nostri nipoti.
I nostri valori - dobbiamo esserne consapevoli - in questi decenni, sono passati (x2), anche se, talvolta, a trasmetterli è stato qualcun altro. Ma dobbiamo anche essere sempre più consapevoli che i settori di cui ci occupiamo vivono in una dimensione di incertezza mai vista prima. Una crisi climatica strutturale, mestieri che non trovano ricambio generazionale, osterie che chiudono e aree interne che vengono abbandonate per sempre. Per avere credibilità, e così arrivo anche a un quarto punto, dobbiamo saper essere creativi.
Creativi con il linguaggio, creativi con la comunicazione, creativi perché essere creativi è l’unico modo che ci allontana da un mondo standardizzato. Fateci caso, questo l’ho imparato recentemente da una persona speciale, il verbo creare presuppone solo cose belle, positive. Per tutto il resto c’è il verbo distruggere.
Non posso che chiudere tornando a quel numero 4 con cui mi sono presentato. E chiudo dicendo che vediamo i prossimi 4 anni come anni interessanti, forse più intensi, forse più difficili di quelli appena passati. Ma di una cosa sono convinto, visto che dobbiamo soffiare su delle candeline che poche associazioni sono riuscite spegnere.
Ebbene, voglio dire che dopo 40 anni di semina, per slow food, se lo vogliamo davvero, il prossimo futuro può essere il tempo del raccolto.
Manca il respiro a vedervi, così tanti e così belli!! Pensare a tutto il tempo trascorso insieme fa mancare il fiato.
Non va nascosto che, malgrado non si tratti della prima occasione, c’è sempre per me più di un filo di emozione che accompagna questi momenti. Emozione vera e sincera, quell’emozione che crea vibrazioni, che rimangono nella mente e nel cuore.
Guardo la platea e vedo moltissimi volti noti, occhi pieni di amicizia e di condivisione. Non mi sfugge che c’è anche un certo numero di volti nuovi, da un lato segno di un tempo che rinnova le responsabilità all’interno del nostro movimento ma segno anche di un movimento che non smette di crescere.
Prendere la parola quale uno dei candidati nel Consiglio Direttivo riempie di energia ma anche di preoccupazione perché si rinnova un impegno che è pieno di responsabilità. Quella responsabilità che deve accompagnare la strada di tutti noi in qualsiasi ambito ciascuno operi.
Nella nostra quotidianità non dobbiamo sottostimare il ruolo che possiamo avere per il reale cambiamento di un sistema del cibo che ancora oggi appare malato, troppo legato ad un modello estrattivistico. Le politiche agricole non riescono mai ad essere allineate con i tempi che stiamo vivendo, rispondono sempre a logiche di profitto ad ogni costo e manifestano una sostanziale incoerenza rispetto agli inequivocabili dati che riflettono un quadro globale inquietante.
Continuiamo a sentire la grande minaccia nei confronti della nostra biodiversità, di quella moltitudine di risorse genetiche che vivono in perfetto equilibrio con gli ecosistemi in cui generazioni di agricoltori, allevatori, casari, piccoli trasformatori, ristoratori, hanno saputo creare comunità e sviluppare prima di tutto cultura e poi anche economia e sviluppo rurale. Su questo dobbiamo tenere ben dritta la linea che abbiamo saputo costruire in decenni di attività associativa, in Italia come all’estero.
E quindi, sono pronto a fare strada con tutti voi, come sempre da moltissimi anni ormai, Sono pronto a dare il mio contributo per rafforzare il nostro impegno sui temi della conservazione di quella diversità culturale che riempie tutte le nostre strade, che ci porta a sostenerne l’impegno contro il buio dell’assimilazione, delle monocolture, dell’esclusione sociale, del profitto a tutti i costi, dell’indifferenza verso l’altro e verso l’ecosistema. Tutti insieme, ognuno con il proprio tempo, con la propria disponibilità, con la propria storia, con i propri strumenti. Questa è la forza della nostra associazione, mettere insieme tutte le nostre diversità per diventare quella moltitudine di voci che fa tanto rumore, con impegno e con amore.
Ieri, qui in Lazio, girando per produttori, ho avuto un’esperienza importante, l’ennesima. Un anziano agricoltore, abituato a fare i mercati con i suoi prodotti agroecologici, amareggiato mi ha detto ‘dobbiamo cercare di nuovo i sorrisi della gente, in giro non si sorride più’. Insieme a noi c’era Said, un ragazzo del Bangladesh che dopo aver lavorato per anni nei campi della Tuscia si è visto circondato da grande spirito di integrazione ed inclusione e ha avuto finanziato il suo primo insediamento da giovane agricoltore nelle terre messe a disposizione dai suoi datori di lavoro. È nata una nuova azienda agricola, piccola ma piena di speranza, e Said l’ha chiamata il Sogno. Ecco, su queste esperienze vorrei che fondassimo il nostro impegno anche con gli agricoltori, rafforzando la speranza di quelli giovani senza mai perdere la ricerca dei sorrisi. Proprio come sollecitato qui oggi da Edie.
Sono molto orgoglioso della presenza di Edie oggi qui a Roma, segno di un’unicità di voce e di obiettivi che è l’unico strumento che può davvero trascinare questo movimento verso grandi risultati. Grazie Edie per le tue parole importantissime. Quando nel gennaio scorso è uscita ufficialmente la composizione del gruppo oggi qui candidato, il mio primo impegno è stato quello di scrivere un messaggio a Edie per dirgli di aver ritenuto giusto mettermi a disposizione dell’associazione come sempre e per confermargli che non sarei comunque venuto meno agli impegni assunti nel board di Slow Food Internazionale. E – vi confesso – conservo molto gelosamente il messaggio di risposta di Edie che con intelligenza, lungimiranza e grande affettuosità ha abbracciato questa mia scelta e mi ha garantito con entusiasmo il suo sostegno, il suo appoggio e il suo incoraggiamento.
Vorrei concludere questo breve intervento sottolineando un aspetto che a mio modo di vedere non può, non deve rimanere sottinteso o trascurato. La parola chiave che unisce tutti in questa sala, che unisce le migliaia di soci e attivisti in giro per l’Italia e per il mondo è e rimane una: la generosità. Non riesco a distaccarmi da questo pensiero, ovunque io vada. Rimango spesso in silenzio ad osservare comitati di condotte, fiduciari, soci, comunità. E mi rendo sempre più conto che
- è la generosità che ci sostiene, che ci porta oggi ad essere tutti qui dentro,
- è la generosità che ci porta a essere attivi nei nostri territori con ogni piccola iniziativa, ed
- è la generosità delle nostre famiglie che ci stanno accanto in quello che facciamo, che rinunziano a noi e al nostro tempo per permetterci di fare tutto questo.
- È la generosità delle decine di colleghe e di colleghi che a Bra vanno ben oltre il proprio semplice impegno lavorativo garantendo una rete di relazioni ininterrotta e sempre viva.
Questa generosità non ha un prezzo quantificabile pur rimanendo, a mio modo di vedere, il valore più alto che la nostra associazione, il movimento tutto, sa esprimere per portare avanti valori politici pieni di grande significato per il nostro ecosistema e per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Prima parlavo solo di figli, oggi che l’età avanza, parlo anche di nipoti.
E allora, come Said nella Tuscia, dobbiamo credere sempre al nostro grande sogno di cambiare il mondo, di creare un nuovo modello di futuro, di relazioni, di condivisioni, di progetti. Mai smettere quindi di sognare. Grazie a tutti e viva Slow Food
Registrazioni video
Innanzitutto i miei complimenti a tutti voi per questa assise così sentita, così partecipata, in questo particolare momento storico di confusione che stiamo attraversando. Ogni congresso di un’associazione è chiamato in qualche modo a scegliere delle vie, delle ipotesi, nuove suggestioni. Molto bello è stato l’intervento di chi mi ha preceduto, che ci invita ad aprire il movimento all'attenzione verso i migranti. Fare in modo che essi stessi diventino parte attiva del nostro corpo sociale, e che, in qualche misura, noi diventiamo, come dire, espressione della loro importanza della nostra società. Ma c'è di più, c'è il fatto che dobbiamo tutti avvertire, in questo momento, quanto sia importante implementare la diversità della nostra rete. Questo è un obiettivo mica da poco. Perché noi avvertiamo, oggi più che mai, coma la situazione stia diventando drammatica. E allora è in questo momento che bisogna avere il coraggio di implementare il cambiamento, di rafforzare il cambiamento. Non dobbiamo avere paura di allargare la nostra rete e non dobbiamo avere paura di fare in modo che la nostra rete non sia, come dire, anche territorialmente rappresentata da un solo gruppo: può darsi che ci siano diversi gruppi. Non vi siete mai chiesti perché non abbiamo tutto sto successo con i giovani? Molti fiduciari dicono che nella loro condotta ci sono dei giovani molto bravi. E quando chiedo quale ruolo hanno, la risposta è che sì fanno delle cose, ma il comando è sempre nelle solite mani. È forse giunto il momento di lasciare ai giovani il diritto-dovere di realizzare loro una condotta, una forma associativa? E quindi di implementare la nostra diversità? Io dico di sì. Non dobbiamo avere paura: possiamo convivere nella stessa casa, nella diversità. È ora di cambiare un po’ quello che per tanto tempo è stato il nostro slogan “Uniti nella diversità”. È ora di ribaltarlo “Diversi dell'unità”.
Non è un gioco di parole, perché se noi mettiamo come valore forte della nostra identità la diversità e lavoriamo su questo, in quel momento rafforziamo la nostra identità. E rafforziamo anche il senso di unità che ci dia piacere, che ci dia soddisfazione. Allora, forse, è giusto il tempo di fare una riflessione. Una riflessione che voglio condividere con voi. La riflessione è questa. Qual è la ragione d'essere del nostro movimento? Perché esistiamo? Qual è l'elemento precipuo della nostra esistenza? Non è di tipo prettamente politico. In particolare, quando la politica si identifica nelle sue forme partitiche. Siamo qui in assemblea per eleggere un gruppo dirigente, ma non è questo è il nostro obiettivo primario, non è questa la nostra partita. Va da sé che la nostra non è una realtà di tipo religioso. E neanche di tipo sociopolitico. E quando dico sociopolitico penso a movimenti, a realtà che tutelano una professione. Penso ai sindacati. Sono movimenti la cui ragione di esistere è dare forza alle realtà che rappresentano. La vera ragion d'essere del nostro movimento è la vostra felicità. Noi non siamo qui per pagare dazio a una realtà di tipo politico. Noi siamo qui perché ci piace stare qui, perché ci piace stare nell'Associazione, perché dell'associazione proviamo un senso di realizzazione, questo è il primo scopo del nostro movimento. E sbagliano coloro che ritengono che il sottotitolo “movimento internazionale per la tutela del diritto al piacere” sia unicamente collegato al cibo. Tutela del diritto al piacere riguarda anche il piacere di militare in questa associazione. Noi dobbiamo avere piacere di essere qua dentro, noi dobbiamo provare piacere per quello che facciamo. Essere gioiosi per questo. Ho sempre detto che hanno fatto più danni tutti coloro che hanno sofferto per gli altri, piuttosto che coloro che hanno goduto per se stessi.
Come può essere credibile uno che va in giro col magone a dire quanto importante è il suo ruolo? In tutti questi anni io ho sempre trovato piacere a stare dentro questo movimento. E sarei illogico se dicessi che ho sofferto. Nessuna sofferenza, anzi, ha dato senso alla mia vita. E quando mi guardo attorno e vedo quante cose fatte, quante attività abbiamo messo in moto, quante persone ho incontrato. Quante persone sono entrate e altrettante sono uscite. Ebbene, io dico che l'elemento distintivo prioritario di tutti i gruppi dirigenti di questo straordinario movimento è sempre stato essere pienamente soddisfatti e pienamente realizzati nell'essere militanti. E questa è una cosa importante.
Due sono gli elementi da non perdere di vista.
Il primo. Dare valore al fatto che siamo un movimento che opera dal basso. E fa in modo che le cose cambino, perché, la sua maggior ragione d’essere è lavorare con la gente, per la gente, perché le cose cambino dal basso. Questo è importante, questo è quello che abbiamo sempre fatto. In qualche misura è quello che ci ha sempre caratterizzati. Non dimenticherò mai che in uno degli ultimi incontri con Papa Francesco, parlando delle comunità Laudato Si’, lui mi disse “ricordati che il mondo si cambia dal basso. Mantenete questa dimensione. Perché non si è mai visto cambiare la natura dell'acqua in vapore mettendo il fuoco di sopra”. Da sotto che si carica, noi dobbiamo essere coscienti di questo, anzi dobbiamo trovare gioia per realizzare questo, noi dobbiamo avere coscienza che nel momento in cui riusciamo a fare bollire l'acqua, abbiamo già svolto una gran parte della nostra missione. Noi dobbiamo far bollire quest'acqua, dobbiamo fare in modo che le cose cambino e cambino perché noi operiamo con gioia e con letizia dal basso, con la gente.
Il secondo elemento che dobbiamo avere tutti ben chiaro è che quello che stiamo realizzando non esiste solo qui in Italia, lo sta realizzando gente come noi in ogni parte del mondo. In ogni parte del mondo c'è qualcuno di Slow Food che fa bollire l'acqua. Lo fanno in un modo originale, lo fanno in un modo diverso dal nostro. E allora come non guardare a queste realtà? Come non essere orgogliosi di far parte di questa rete? Perché questa è la politica, questa è la rete politica che cambia il mondo. E allora io guardo con estrema gioia al fatto che i giovani dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo sono venuti a propormi un'iniziativa sulla Cisgiordania che vi riporto qui. Si tratta di un villaggio della Cisgiordania dove i bambini per andare a scuola fanno 7 km a piedi, passando accanto ai villaggi dei coloni. Molte volte vengono bistrattati, minacciati, molte volte non riescono ad arrivare alla scuola. I nostri giovani hanno messo in essere un meccanismo per realizzare quattro aule elementari per avere la scuola nel villaggio gestita dai loro padri, dai palestinesi. Chi è cosciente che questa iniziativa è più potente di tutte le ciance? Chi ha coscienza che questo progetto è molto più significativo di tutti i nostri attestati. Perché io mi sento impotente davanti alla criminale logica portata avanti dal governo israeliano. Non possiamo cavarcela con un minuto di silenzio, perché come si dice in Langa “poco è poco, niente è troppo poco”. Allora cosa possiamo fare. Se in questa sala dove siamo in 500 mettessimo 100 euro raccogliamo 50.000 euro e la scuola è fatta. Ma faremo anche altre cose. Perché, guarda caso, dove c’è una guerra di cui nessuno parla, quella del Congo, c'è un gruppo di giovani di Slow Food che fanno gli orti. In una recente telefonata con loro, sentivo le armi suonare. Loro devono avere coscienza che non sono soli, loro devono avere coscienza che quello che fanno è straordinario e che noi guardiamo a loro con affetto, con gratitudine per come tengono in alto il nome del nostro movimento. E ho ancora negli occhi lo stupore di un giovane che ha preso un premio di 4000 euro dedicato alla nostra ex Presidente di Slow Food Germania. Questo giovane gestisce degli orti nella frontiera tra Uganda ed Etiopia, anch’essa tormentata dalla guerra. Era senza parole. La cifra è stata fondamentale per la sua attività. È la che coltiva e dà da mangiare a tantissime persone. Lui è là, a testimoniare l’attività di Slow Food, lui è Slow Food.
Un'altra cosa. Dal momento in cui Gaza è inaccessibile anche agli aiuti, noi dobbiamo ritessere le fila e fare qualcosa per loro e abbiamo l'opportunità di farlo con quel parroco a cui Papa Francesco tutti i giorni telefonava. Noi possiamo avere un rapporto con lui e fare in modo che lui possa dare vivande, aiuti economici, aiuti sanitari alla sua popolazione. Cosa aspettiamo! 100 euro a testa? 100 euro a testa. Ecco, questo è il modo di essere internazionali, questo è il modo di lavorare dal basso. Due nostri ex studenti di Pollenzo, in un'area del Kenya con la partecipazione di decine e decine di contadini, hanno realizzato 200 orti che danno da mangiare a 200.000 persone. Siamo coscienti che sono della nostra famiglia. E nel momento in cui la guerra sta per arrivare anche in Kenya che sarà di quei 200 orti? Che ne sarà di quel cibo per 200.000 persone? E quelle 200.000 persone pur non conoscendo che cos'è Slow Food, parlano di Slow Food. È questa la potenza che noi dobbiamo essere coscienti di avere e vi pare che questa potenza si può fermare semplicemente perché noi mettiamo la targhetta di diritto di essere Slow Food? Apriamo le nostre porte, non abbiamo paura.
Portiamo avanti con serietà questo rituale della democrazia partecipativa. E voglio dire una cosa al nuovo gruppo dirigente. Il compito primario che voi dovete avere nei prossimi anni è implementare questa gioia di partecipare e fare in modo che non possa mai venir meno il senso di partecipazione attiva, che è la cosa più importante che noi abbiamo. Ecco non strutturiamoci troppo. Quando siamo troppo strutturati non siamo più noi, per nostra natura siamo sempre stati un po’ ballerini. Ve lo dice uno che su questo concetto di ballerino ci ha messo anima e corpo, e quindi quando mi dicevano bisogna rafforzare la rete strutturale, rispondevo lasciala andare, lasciala andare. Perché se è pur vero che il pilastro numero uno è l'intelligenza affettiva, il secondo pilastro è l’austera anarchia. Oggi vorrei cambiare questo secondo pilastro con gioiosa. Gioiosa anarchia. Noi troviamo gioia nel fare, ognuno nel fare quello che si sente di fare. Non è diritto mio venire a sindacare se in una regione, in un'altra, se in una parte del mondo non seguono le regole stabilite dai congressi. Noi dobbiamo semplicemente dire che più c'è partecipazione, più c'è diversità, più siamo forti. È questo che non capiscono gli altri, gli altri pretendono di avere l'unità per incidere nel cambiamento. Noi invece cambiamo con la nostra diversità e la nostra diversità è all’origine del cambiamento. Questo è l'elemento più importante che dobbiamo avere a cuore in questa fase. Vi chiedo scusa di questa esegesi organizzativa, però, visto che sono un po’ a fine corsa, accettatela come una riflessione di chi ci è già passato. Non ripetete gli errori, fate in modo che l’originalità sia a tutti gli effetti forte e vivace.
E un’ultima cosa. Una cosa importante. Siate coscienti che in tutti questi anni nelle varie realtà in cui abbiamo operato, noi abbiamo sempre messo nuove idee, nuove proposte. Pensare alla prossima Terra Madre basata su quella che è la nostra spina dorsale: l'Arca del gusto, i Presìdi. Dietro quell'Arca, dietro quei Presìdi ci stanno persone, giovani che dall'essere parte attiva ne ricavano anche l'orgoglio per il loro lavoro. Dietro quell'Arca, dietro quei Presìdi ci sta la nuova associazione che deve aprirsi. Pensate chi sono e come si muovono. Pensate quanto sono in sintonia con noi, pensate quanto ci possono dare. Dobbiamo imparare anche da loro. E questa è un'opportuna, è come aprire le finestre. Basta con questa logica concentrata unicamente sul cibo. Concentriamo prioritariamente la logica del piacere di fare quello che facciamo e dell'essere tra di noi coscienti che abbiamo la nostra identità planetaria. Una cosa su tutte, vi devo dire. Vi ringrazio per quello che fate e vi voglio un gran bene.
Thank you all for coming together at this moment and in this historical place. There is a lot going on in the world from wrong political choices, wrong economic and political decisions some of which are against our freedom and a right to live, the wars and not to mention the climate crisis.
We all face these same global challenges but again there is a lot we call all do together to overcome them atleast enable someone out there overcome such unfortunate situations
In strongest terms possible, we condemn the criminality, the genocide and the never ending suffering endured by innocent people in Gaza, Ukraine, Congo, Sudan and many other areas of conflict and ward.
Like many other conflicts that we never hear of, The Gold rich region of north eastern Uganda suffered all forms of violence and it in constant armed conflict just Like Congo and Sudan.
A lot of people lost hope and ability to feed themselves, but have kept a strong connection with Slow Food. At Terra Madre, with the Ursula Hudson award, we supported a young indigenous community leader Ochen Bashir to support slow food communities establish gardens, organise training on agroecological food production as well as collecting indigenous seeds for the communities to plant.
The results are encouraging and hope for these communities to feed themselves has been restored. This is a small action taken by the Slow Food Network in one of the many conflict torn zones to change life for better. We should continue to do this and you should be part of the solution.As Slow Food international we have already committed and decided to support with donations to support the communities in Gaza, Sudan and Congo as we have already done in Ukraine. These small donations are a drop in the sea but can have a big impact like they did for Bashir in Northern Uganda.
And beyond this, we need to extend our hands and hearts beyond ourselves and our national Boundaries.
Nationalism is the evil we must fight. A good, clean, and fair world can only exist if there are no barriers, no walls, no individualism. It is selfish and illogical to think that you have the freedom to travel everywhere in the world but others don’t.
Food is the perfect example of cross-cultural exchange, of growth through migration and sharing. That is why sharing and caring for one another through this global family must be the priority for all of us beyond borders.
Carlo always calls us to have this emotional intelligence and social solidarity as the driving force for the growth of our movement. We need to embrace this level of intelligence to overcome Nationalism.
Slow Food has always fought against nationalism—it’s the same principle that inspired the creation of Terra Madre.
The idea was to put farmers and food producers at the center of political discourse (a global meeting of food communities), and to do so globally, without distinctions of origin, ideology, race, religion, sex, etc.—everyone on the same level.
Today, this battle is more important than ever. We are about to hold Terra Madre Americas, the event dedicated to the entire American continent: for the first time in our history, we have more money available for delegates from South America than we have delegates willing to attend. People are afraid to go to the United States. That has never happened before—but it is happening now.
Never before has this battle been so important.
Never before has a movement like Slow Food needed to put diversity and solidarity at its core. Never before has Slow Food needed to reclaim the original spirit of Terra Madre. Never before has it been so necessary to reclaim the spirit that led to the creation of the first thousand gardens in Africa—a project that had an enormous impact and changed the lives of thousands of people.
And I certainly don’t need to tell you—our Italian network—this. You were the first supporters of the project, the ones who donated the most, the most engaged, the ones who made the project a success. We will never stop being grateful to the Italian network for everything it has done.
Today’s invitation and wish is to strengthen relationships, to work together. To open the doors of your local groups to the rest of the world. To explore forms of collaboration, of exchange, of cross-cultural connection, of learning, of fraternity.
To bring together many small daily actions that, all together, can have the kind of impact that only a movement like ours can create.
I’ll never tire of saying that, considering all the events that Slow Food organizes around the world, there’s a Slow Food event happening every twenty minutes somewhere on the planet. To learn from each other and—let’s never forget—to unite the pleasure of food and sharing with the responsibility each of us has to change the world.
And that’s done through small daily actions, not through lots of social media likes—which are fine, but they don’t change people’s lives.
I am at your full disposal to visit your territories, to share the experiences of our global network—its successes, its weaknesses, its challenges. I would very much like, during the course of 2026, to travel across Italy to get to know the strongest and most impactful network in the world, to build bonds, and to help share with all of you and your members the global challenges we are facing.
Challenges we will only overcome if we are united, if we think globally, if the emotional intelligence Carlo has always spoken of continues—and in some cases returns—to permeate our daily lives and remains at the core of who we are.
I hope to meet and get to know you in person, if not today (unfortunately I must return to Uganda and cannot stay with you for the whole duration of the assembly), then in the coming months and years, to fight side by side for food that is more good, clean, and fair for everyone, in every corner of the planet.
I wish you Joy and Good luck in everything you do for Good, Clean and Fair Food.Un’altra idea di cibo è possibile
Nicola Perullo, filosofo, Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Un’altra idea di mondo – amo particolarmente il tema del congresso nazionale di Slow Food Italia2025. Già, ma cos’è il mondo?
Il mondo siamo noi, non è niente di staccato e separato da noi. Il mondo non è qualcosa cheosserviamo a distanza e, come è stato giustamente osservato da tanti filosofi, il mondo non si cambiacome si cambia un vestito, un’automobile o un telefono perché il mondo non è un oggetto né unacosa. Il mondo, come diceva un famoso filosofo, è tutto ciò che accade e oggi sappiamo, anche graziealle scienze, che tutto ciò che accade è intrecciato, interconnesso. Dunque, non si può cambiare ilmondo se non si cambia innanzitutto il modo in cui lo abitiamo, lo viviamo, lo sentiamo e lopensiamo. E per cambiare il modo in cui lo abitiamo, lo viviamo, sentiamo e pensiamo, occorre fondamentalmente modificare il mondo in cui percepiamo noi stessi e le cose. Tutte le cose con le quali condividiamo la nostra esistenza: gli altri animali, i vegetali la realtà minerale. Ogni forma di vitasulla terra. Il mondo è un vero e proprio condominio: Homo vi abita ma non ne possiede l’esclusiva. Anzi, volendo continuare con la metafora condominiale, Homo dispone di pochi millesimi: ci sono abitanti molto più numerosi, grandi e antichi. E tuttavia, l’umano ha qualche responsabilità che glialtri viventi non hanno, sia perché ha una vita molto dispendiosa sia perché – o forse proprio perché consuma molto – ha il compito di gestire il condominio.
Come si fa a cambiare prospettiva, come si può cambiare il nostro sentire/pensare cioè percepire ilmondo? Il cibo è un’occasione formidabile per provare a farlo. Il cibo è infatti il più evidente segno dicompartecipazione al mondo: il cibo si produce, si elabora e si
mangia nella continua collaborazione di tutti i viventi – minerali, vegetali, animali – del pianeta.Dobbiamo dunque modificare una stortura a cui la nostra mentalità più moderna e scientifica ci haabituato, quella di vedere il cibo come un oggetto da misurare e di cui appropriarsi nella divorazione.E passare invece a percepire il cibo come un insieme di processi, come una corrispondenza dinamica:sentire/pensare-con il cibo significa viverlo come una relazione, come una continua domanda a cui siamo tenuti a rispondere. Responsabilità: questa parola, a cui facciamo spesso ricorso senzacomprenderla fino in fondo, significa in realtà capacità di rispondere. Ma si risponde soltanto se sisente che il nostro interlocutore ci pone domande e chiede di essere riconosciuto. Il cibo è il nostro principale interlocutore, non è un oggetto di cui appropriarsi. Il cibo è una rete: tornare a percepire ilgustare in primo luogo non come esclusiva valutazione sensoriale di un oggetto ma come una domanda, scoperta, punto di attenzione e di ascolto. Gustare è una risonanza di collaborazione, compassione,condivisione che rimanda a processi: dalla produzione al consumo, dalla trasformazione alle tradizioni, agli stili, alle storie. Il cibo è relazione: assaggiamo una verdura, un legume, un formaggio,un pane, una bevanda e ascoltiamo le maglie, le interconnessioni che il mondo ci presenta. Percepire-con il cibo significa entrare in risonanza con la bellezza o con la miseria che ci viene incontro e che richiede una capacità di rispondere che, a un certo punto della nostra evoluzione umana, abbiamo cominciato a perdere e dimenticare. Occorre rieducarci a questa capacità.
Un’altra idea di cibo è possibile: questo è, io credo, l’insegnamento più profondo, radicale e imperituro che Slow Food ha mostrato al mondo intero, e che continua oggi a risuonare nelle visioni enei progetti che porta avanti.La sfida dell'intelligenza artificiale
Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità
In un episodio di Caro diario Nanni Moretti racconta una difficile esperienza di malattia, un prurito violento e continuo che aggredisce il suo corpo. Inizia così un pellegrinaggio dai migliori dermatologhi, ognuno dei quali prescrive nuovi medicinali. Si ritrova così con decine di farmaci ma il prurito non guarisce. Allora decide di leggere tutti i fogli di istruzioni – lavoro improbo, testi ipertrofici e formato molto piccolo - e capisce che quasi tutti quei medicinali non servono allo scopo e li butta. Guarirà poi grazie ad una diagnosi diversa, ma non è questo che ci interessa. Moretti non si rivolge a Google o Wikipedia, va alla fonte e analizza attentamente la composizione e l’utilizzo dei farmaci. È un atteggiamento che possiamo definire neoumanistico: rifiutare verità imposte e incontrollabili, come il teocentrismo.
Il destino che incombe sull’umanità oggi è quello di un dominio sempre più stringente dell’intelligenza artificiale in senso lato, un nuovo teocentrismo fondato sull’uso smodato, per certi versi delirante, di supporti tecnologici, come telefonini, tablet, piattaforme, banche dati, eccetera.
Nel Documento di Roma – totalmente condivisibile – manca questo aspetto del futuro che ci attende: eppure è una sfida che Slow Food deve raccogliere. Il progetto neoumanistico deve combattere contro un potere che si sta imponendo, quello dell’intelligenza artificiale, che travolgerà tutti gli aspetti della vita sul pianeta. Non vuol dire abbandonare l’uso delle comodità tecnologiche, né invocare una sorta di luddismo moderno. Come cercare un cibo buono, pulito e giusto non vuol dire assaltare i supermercati e distruggere i cibi industriali. Vuol dire impegnare tempo ed energie per produrlo e mangiarlo.
Andare alla fonte, non fidarsi, studiare, leggere, scambiare idee e progetti, non vivere con il telefonino in mano, questo lo possiamo fare.
Ricordatevi: il giorno che alla stupida richiesta di dichiarare “non sono un robot” ci risponderà proprio un robot, sarà finita.
Riconosciamoci e diamoci spazio
Cinzia Scaffidi, socia e collaboratrice storica di Slow Food
Grazie per questo invito, che mi ha fatto davvero piacere.
Purtroppo non potrò essere con voi, per questioni di lavoro e in parte anche di famiglia, ma apprezzo tantissimo che abbiate pensato a me.
Slow Food è stata ed è una parte della mia storia, e spero di poter dire anche viceversa.
È un momento duro: questo mondo, in caduta libera verso il peggio che abbiamo mai immaginato, sembra non poter in alcun modo beneficiare delle idee che hanno guidato il nostro movimento. Parliamo di tutela della biodiversità dei cereali mentre i bambini saltano per aria a Gaza? Parliamo di residui di pesticidi nella verdura mentre si bombardano i centri in cui viene arricchito l'Uranio? Parliamo di tutela dei diritti dei braccianti nelle vigne di Langa mentre in Libia uomini, donne e bambini vengono quotidianamente stuprati, torturati e uccisi?
La tentazione intellettuale di gettare la spugna, a volte, fa capolino. Poi, per fortuna, arrivano a salvarci - ancora una volta - le parole che abbiamo letto e che ci hanno costruito nel tempo:
"L'inferno dei viventi - scriveva Italo Calvino più di cinquant'anni fa - non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio".
Ecco il compito di Slow Food, e di ognuno di noi, in questo mondo che ha perso il senno: riconoscere questo movimento, ogni singola persona che ne fa parte e tutte le organizzazioni con cui facciamo rete, come un pezzetto di ciò che inferno non è. E farlo durare. E dargli spazio. Non nascondiamo, non depotenziamo il bene che sappiamo fare - e che sappiamo di dover fare - solo perché il male ci pare infinitamente più potente, più dotato, più ricco, più diffuso. Quello è l'inferno. È un incendio da spegnere, forse è un incendio che completamente non si spegnerà mai, questo lo possiamo ammettere. Ci sarà sempre un altro pazzo che inizierà una nuova o vecchia guerra, che farà una nuova legge ingiusta, che farà prevalere un reato. Quello che non dobbiamo accettare è di confonderci con gli incendiari, condividerne le colpe e le responsabilità: noi non siamo inferno.
Riconosciamoci e diamoci spazio, facciamo durare la nostra azione nel mondo.
Vi abbraccio e vi auguro buon lavoro. Anche se non potrò essere a Roma, non farò mai mancare i miei pensieri, per quel nulla che contano, alla nostra associazione, lo sapete.
Cibo e città: una riflessione per nutrire qualità della vita, paesaggio e comunità
Carmine Maturo, Slow Food Napoli
Le città sono oggi spazi centrali nella vita di milioni di persone.
Ed è proprio in questi luoghi – densi, complessi, contraddittori – che il cibo ha in parte perso il suo significato più profondo.
Insegne luminose, locali alla moda, file per lo street food più instagrammabile: il cibo è ovunque, ma sempre più spesso ridotto a spettacolo.
Nel frattempo, le osterie scompaiono, le ricette si semplificano, le produzioni locali faticano a reggere la pressione del turismo veloce e della movida.
I piatti tipici diventano souvenir. E le persone, spesso, consumano senza sapere da dove proviene ciò che mangiano.
Questa trasformazione ci riguarda da vicino, anche come attivisti Slow Food.
Perché tocca il senso stesso del nostro impegno: il cibo come cultura, come relazione, come diritto.
È nelle città – e non solo nelle campagne – che oggi si gioca una partita cruciale. Cibo e qualità della vita urbana sono legati più di quanto sembri.
Una città che offre cibo buono, pulito e giusto è anche una città più verde, più sana, più conviviale, più equa.
Per questo, potrebbe essere utile aprire una riflessione condivisa tra condotte, comunità urbane, cuochi, produttori e cittadini, con l’obiettivo di costruire una nuova alleanza tra cibo, città e paesaggio.
Gli spunti da cui partire potrebbero essere:
- Rimettere al centro i piatti tipici, non come folklore da esibire, ma come ponti vivi tra passato e futuro, tra città e territori rurali. In questo senso, le periferie urbane potrebbero diventare luoghi-ponte strategici, dove far rinascere saperi, relazioni e filiere corte.
- Rilanciare con forza la dieta mediterranea e la cucina stagionale e vegetale, non solo per motivi ambientali e sanitari, ma anche culturali: piatti semplici, territoriali, che raccontano biodiversità, clima e memoria.
- Guardare al cibo come parte del paesaggio urbano: il mercato di quartiere, il parco con l’orto condiviso, la mensa scolastica sostenibile, la trattoria che cucina ingredienti locali… Tutti elementi che costruiscono vivibilità e bellezza.
- Parlare di cibo come diritto: accessibile a tutte e tutti, in ogni quartiere, a ogni età, senza distinzione di reddito o condizione. Il cibo giusto non può essere un lusso.
- Interrogarci sul turismo alimentare: come evitare che il gusto si svuoti in una logica di consumo usa-e-getta? Come proporre esperienze autentiche, lente, rispettose delle persone e dei luoghi?
- Ripensare il fast food urbano: in molte città è la sola opzione per chi ha poco tempo o pochi mezzi. Ma può esistere un fast good accessibile, sostenibile e comunitario?
La proposta è quella di aprire uno spazio collettivo di confronto, ascolto e sperimentazione.
Di immaginare, insieme, come Slow Food possa essere guida in questa nuova sfida: Far tornare il cibo a essere infrastruttura culturale, ambientale e sociale delle città.
Una città che nutre bene è una città che si prende cura.
Che accoglie, educa, crea bellezza, restituisce tempo e dignità.
Nei territori, già molto si muove: il congresso potrebbe essere l’occasione giusta per avviare il confronto e la connessione fra queste esperienze, a partire dalle cittá metropolitane, approfondirle e dar loro voce.Fare del cibo urbano una nuova frontiera della nostra azione nelle città.
Slow Food: il suolo come orologio della lentezza umana. Proposte.
Mauro Avino, Slow Food Costiera Sorrentina e Capri
Qualche mese fa, mentre organizzavo una mattinata nell’orto didattico con i bambini di una scuola primaria, una mamma salutò il gruppo dicendo: «Una mattinata, finalmente, lontano dai cellulari». Quelle parole hanno indotto in me una profonda riflessione.
Slow Food nel 1986 introdusse la parola «slow» come concetto spiazzante ed antidoto alle prime luci al neon dei fast‑food. Da allora però il mondo ha ingranato marce che non potevamo immaginare.
Oggi siamo quotidianamente investiti da una incessante tempesta mediatica di immagini e notifiche che
riversano sui nostri sensi a una velocità impensabile emozioni immediate e contrastanti: immagini leggere e accattivanti accanto a rappresentazioni drammatiche senza filtro. Un tempo tali immagini avrebbero
innescato in noi meraviglia o orrore, oggi scorrono via prima che il cervello abbia la possibilità di elaborarle. Ci viene sottratto il tempo fisiologico necessario per stupirci, indignarci e perfino ribellarci. Mancando questa pausa, i messaggi si annullano a vicenda: all’entusiasmo segue subito lo sgomento, alla compassione il cinismo. Così perdiamo la capacità di formare un giudizio autonomo, di stabilire punti di riferimento, di costruire quella trama di valori che chiamiamo “morale condivisa”.
Proprio perché l’uomo si alimenta di cibo e di informazioni, difendere la lentezza significa prendersi cura di entrambi i suoi nutrimenti primari. Come essere umani funzioniamo per essere tarati sulle albe e sui tramonti, la nostra mente sui cicli del sonno, il cuore sul respiro. Per questo la lentezza, lungi dall’essere
inattività, è una scelta politica. Produrre meglio, nutrire meglio, vivere meglio, con il ritmo giusto per l’uomo e per il pianeta, secondo gli obiettivi degli SDG dell’Agenda 2030 dell’ONU.
“La lentezza è una competenza, non un difetto”, la terra è il nostro metronomo naturale. Pensiamo ai Presìdi Slow Food: la lenticchia di Ustica, il fagiolo di Controne, il Caciocavallo podolico. Ognuno racchiude mesi di cura, di attesa, di ascolto. Nei Mercati della Terra, il calendario agricolo diventa tempo di relazione con il cibo: impariamo a desiderare ciò che non c’è ancora, a riconoscere l’arrivo di un formaggio stagionato come il ritorno di un amico. A tavola, la convivialità ci restituisce il tempo dell’altro; nei viaggi con le Comunità Slow Food Travel, il ritmo del territorio si misura in curve, soste e racconti.
Se – come ci ricorda il filosofo Nicola Perullo – «il gusto è relazione», oggi possiamo dire che il gusto è soprattutto il "tempo della relazione". Un formaggio a latte crudo parla della stalla, dell’erba, delle mani del casaro, ma parla anche della nostra facoltà di ascoltare, del tempo che ci è necessario per costruire etica.
Nella nostra stessa denominazione — Slow Food — convivono due parole. Negli ultimi anni, forse presi
dall’urgenza di salvare razze autoctone e tradizioni gastronomiche, abbiamo lasciato che la seconda, «Food», nel suo significato più comune, occupasse la scena. È venuta l’ora di ribaltare la prospettiva: mettere
«Slow» al centro come scelta politica e lasciarci guidare da essa nel custodire il cibo e la terra, pietra angolare dei bisogni dell’uomo. Come unico movimento globale presente in oltre 160 Paesi, possiamo affermare che la lentezza non è un privilegio, ma un diritto collettivo che restituisce umanità e senso.
La nostra capacità tecnologica deve permettersi di «saltare un giro», di “saltare una generazione” di
innovazioni, proprio come in agricoltura arriva il momento di mettere a riposo la terra. Diamo priorità alla cura dell’anima e del pianeta che calpestiamo, rallentiamo la competizione planetaria: solo così potremo tornare davvero umani.
Da qui alcune proposte, semplici ma concrete: A. Inserire fra i pilastri di Slow Food la tutela delle capacità cognitive – attenzione, memoria, apprendimento profondo, da tutelare attraverso il raddoppio degli Orti
didattici nelle Scuole entro il 2027, accompagnati da esercizi di lettura lenta e di ascolto. B. Elaborare entro il 2026 un paper di posizione del movimento sulla regolamentazione delle intelligenze artificiali, affinché l’innovazione proceda al passo dell’etica.
Prendersi tempo è un atto di cura, diceva Carlo Petrini, «il piacere è la chiave per cambiare il mondo». Oggi aggiungo: il piacere richiede tempo, e "il tempo va protetto". Custodendo la lentezza della terra, custodiamo la lentezza della mente, e con essa la dignità dell’essere umano.
Slow Grains Lombardia
Davide Cinquanta
Cereali autunno-vernini, cereali da paglia, cereali da spiga – che non è una spiga.
Frumenti, orzi, Segali, Avene, una grande famiglia che prende il nome da una dea, la
romana Cerere. La loro Storia è la nostra Storia, fin dai lontani tempi in cui cominciammo a chiamarci Umanità.
La vera forza non è nel glutine, ma nei saperi e nelle tecniche secolari in quotidiana evoluzione che hanno prodotto l’immensa varietà di cibi derivati dai grani: pane, pasta, cuscus, birra, distillati, seitan…
La Lombardia è una regione divisa in due: le zone collinari e montuose delle fasce alpine, prealpine e appenniniche, e le vaste aree della Pianura Padana.
Nelle aree montane una mancanza di politiche adeguate ed investimenti volti a modernizzare il settore agro-alimentare sta provocando una profonda crisi demografica, caratterizzata dalla chiusura di aziende agricole, abbandono dei terreni, spopolamento diffuso. L’abbandono porta a degrado ambientale, perdita di biodiversità, dissesto idrogeologico, perdita di presidio del territorio e di servizi per la popolazione.
L’agricoltura convenzionale non è redditizia nelle aree montane, la riscoperta di varietà e popolazioni locali e, invece, in molti casi, l’unica soluzione remunerativa che può garantire il sostentamento delle aziende.
In pianura l’alto valore dei terreni, vocati all’industria e all’agricoltura su larga scala, ha portato ad una forte erosione della biodiversità, alla frammentazione e spesso scomparsa delle varietà di grani locali esistenti. Il recupero delle varietà è molto difficile in queste aree, per via della loro scarsa redditività.
La rete Slow Grains ha davanti a sé un grande lavoro da compiere in Lombardia, una regione ricchissima di identità e diversità locali, messe a dura prova dagli eventi storici ed economici dell’ultimo secolo, fino a sfiorare in troppi casi l’estinzione.
La rete deve rafforzare il suo legame con gli attori della filiera, produttori e trasformatori, diventando portavoce delle loro istanze sul territorio. Slow Grains deve dialogare con la politica perché metta in atto misure di sostegno finanziario, e costruisca le infrastrutture necessarie, per garantire a tutti i produttori piena libertà di scelta colturale. Libertà di coltivare senza imposizioni politiche o economiche, per portare a compimento la sovranità alimentare delle comunità.
Il rafforzamento della rete Slow Grains nei prossimi anni dovrà creare un ambiente di confronto e dialogo per i suoi aderenti, per combattere l’isolamento che affligge i produttori e mettendo in contatto i coltivatori con i mulini e i trasformatori, fra cui panificatori, pastifici e birrifici artigianali. Slow Grains deve aiutare così i produttori a costruire una filiera completa e funzionale, superando gli ostacoli economici imposti da proprietà tecnologiche dei grani locali richiedono infatti processi e attrezzature dedicate, che non possono essere forniti dalle strutture convenzionali.
La rete Slow Grains deve consolidare la sua presenza anche nel mondo scientifico e accademico, promuovendo percorsi di miglioramento genetico partecipativo, con riferimento al grande lavoro del prof. Salvatore Ceccarelli sulle popolazioni cerealicole nelle aree rurali di Asia e Africa. Grazie al lavoro di Slow Grains la collaborazione tecnica fra coltivatori, trasformatori, università e centri di ricerca può portare ad un notevole sviluppo di tutta la filiera, con benefici e ritorni positivi sui territori
Slow Mays
Rete italiana dei contadini custodi di mais a libera impollinazione
mays@slowfood.it www.slowfood.it/slow-mays
@slowmays
Referenti:
Antonio Rottigni: 340 7531314
Andrea Messa: 329 9020440
Etelca Ridolfo: 331 1694015
Loris Campetti: 370 3117411
Strategia, visione e prossimi passi
Slow Mays nasce per custodire un patrimonio fragile e fondamentale: le varietà tradizionali di mais, i saperi agricoli locali e le comunità che li tramandano. In un tempo segnato da crisi ecologiche, omologazione culturale e abbandono delle aree rurali, Slow Mays si propone come presidio attivo di biodiversità, coesione sociale e sovranità alimentare.
La politica e la strategia di medio periodo della rete si fondano su alcuni assi portanti:
La salvaguardia dei semi locali a impollinazione libera, come beni comuni non brevettabili, strumenti di autonomia per le comunità e veicoli di resilienza ecologica e culturale;
Il sostegno concreto agli agricoltori custodi, attraverso reti di scambio, formazione, promozione e collaborazione, per ridare dignità e forza ai territori e a chi li abita;
La valorizzazione delle culture contadine, intese come patrimonio vivo di conoscenze, relazioni e visioni del mondo;
La promozione di un’agroecologia integrale che coniughi etica, giustizia sociale, tutela ambientale e spiritualità della cura, in un approccio profondamente umano e rigenerativo.
Difendere i semi, le storie e le comunità che li coltivano significa anche dare alle nuove generazioni un punto di partenza solido e autentico: un terreno fertile su cui costruire un mondo più giusto, più consapevole, più in sintonia con i ritmi della natura e con il senso profondo del vivere insieme.
Perché senza radici non si cresce, e senza memoria non si costruisce futuro.
Slow Mays agisce con l’obiettivo di far sì che i semi non siano solo strumenti agricoli, ma segni di una cultura del rispetto, della memoria e del futuro. Agisce affinché il valore dei semi non si esaurisca nel loro uso agricolo, ma venga riconosciuto anche come atto culturale, sociale e politico. Ogni seme è portatore di storie, paesaggi, relazioni e visioni del mondo: custodirlo significa preservare identità, difendere la biodiversità e promuovere un modello di sviluppo radicato nei territori, rispettoso dell’ambiente e generativo di comunità.
In questo, trova una profonda affinità con il festival Lo Spirito del Pianeta, che celebra le culture indigene e tradizionali del mondo come custodi. Così come i popoli nativi rappresentano la saggezza spirituale e comunitaria dei territori, gli agricoltori custodi incarnano una forma di resistenza silenziosa ma potente contro l’estinzione delle diversità culturali e biologiche.
Per questo, il prossimo passo fondamentale sarà il Raduno Nazionale di Slow Mays, dal titolo “Fino all’ultimo seme. Non un agricoltore di meno!”, che si terrà l’1 e 2 agosto 2025, all’interno del Festival Lo Spirito del Pianeta a Piario (BG). Un incontro tra agricoltori, artigiani, cuochi, comunità locali e popoli nativi, per connettere semi e culture, tradizioni e visioni del mondo, in un dialogo che mette al centro la terra e chi la abita.
Oggi siamo chiamati a una scelta che va oltre la conservazione del seme o la tutela della cultura: è in gioco la possibilità stessa di restare umani. Ciò che stiamo difendendo è molto più di una varietà agricola o una ricetta tradizionale. Stiamo salvando insieme la nostra anima.
Osservazioni sui progetti educativi
Teresio Nardi, Slow Food Oltrepo' Pavese
Essere Enti del Terzo Settore ci sta un po’ allontanando da quello che è sempre stato il "CUORE" di Slow Food.
La vecchia CONDOTTA, quella in cui io vorrei tornare a operare, è sempre stata considerata, da me, un gruppo di amici dove ciascuno faceva ciò che poteva o sapeva fare, con il rispetto di tutti gli altri; dove periodicamente ci si incontrava di persona con il piacere di stare insieme, scambiandosi idee e condividendo progetti, approvando il da farsi per i tempi a venire. Il FIDUCIARIO era colui che dettava la linea politica della CONDOTTA, discussa e condivisa da tutti, non stabiliva nulla senza aver sentito i componenti del comitato di condotta.
Oggi tutto è diventato tutto più complesso, le nuove norme del terzo settore ci hanno messo un po’ in difficoltà, ci si trova raramente di persona, le nuove modalità di comunicazione (whatsApp, google MEET) ci consentono di dialogare restando comodamente a casa nostra e raramente ci si vede e ci si sente al telefono!!
Acquisiamo modalità di azione tipiche di un'attività produttiva, ma non siamo un'attività produttiva siamo persone che credono nei principi di Slow Food e che li vogliono divulgare!!
Noi abbiamo a che fare con un mondo produttivo fatto da piccole aziende agricole famigliari, da piccoli produttori spesso in difficoltà e che sono sempre con lo sguardo rivolto verso il cielo nella speranza del buon tempo. Dobbiamo farci conoscere da loro, parlare con loro, convincerli della bontà di ciò che stanno facendo. Ci devono conoscere e ogni tanto vederci, se non a casa loro in un mercato, in una piazza, in un convegno; far con loro due chiacchiere e bere un caffè!!
Questo è molto importante per loro e per noi. Non ci basta dire noi siamo Slow Food, dobbiamo fare in modo che la gente ci indichi come Slow Food e come persone con idee chiare su Etica Sociale, Biodiversità e sul cibo buono - pulito - giusto - per tutti!! Siamo dalla parte giusta e non dobbiamo temere di manifestarlo! Forza giovani Slow Food vi aspetta!!
PROGETTI EDUCATIVI
Slow Food recentemente ha rivolto un forte appello alle Istituzioni affinché venga introdotta l’educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dai più piccoli per far sì che fin dall’infanzia i giovani imparino a scegliere consap volmente ciò che mangiano.
La nostra Presidente, Barbara Nappini, ha efficacemente affermato che un futuro migliore lo si disegna anche attraverso il cibo.
Per raggiungere questo importante obiettivo, dunque, è fondamentale che questa educazione coinvolga tutti, dai cittadini alle Istituzioni Locali, Regionali e Nazionali sulle cui scelte dobbiamo influire!!
- L’etica, la transizione ecologica e la salute passano anche attraverso il cibo
- Lo spreco di cibo è sì fonte di inquinamento ma è soprattutto un inaccettabile insulto al diritto di tutti ad accedervi, principio in cui noi crediamo fermamente ma che è calpestato in moltissimi Paesi, anche in alcuni considerati ricchi, e oggi è diventato anche arma di guerra; Carlin il 23 giugno scorso ha detto: “Affamare i Palestinesi aggravando le loro condizioni umanitarie è un’azione deliberata di chi sceglie di trasformare il cibo in un’arma di guerra”. Su questo fatto Slow Food non può voltarsi da un’altra parte
- L’etica sociale impone di affrontare il diritto al cibo. Quale dignità nella fame? Quale dignità in chi non interviene?
La produzione di cibo è spesso dannosa alla biodiversità, dunque:
- se un pesticida è tossico, occorre toglierlo dal mercato.
- se il Gliphosate è cancerogeno occorre toglierlo da mercato.
- se gli PFAS sono cancerogeni occorre non utilizzarli nella produzione di pentole antiaderenti o altro.
- se pratiche colturali danneggiano il microbiota del suolo non si devono utilizzare.
Le logiche economiche di corto respiro non devono rendere miopi anche coloro che con le norme potrebbero proteggere il futuro dei nostri e loro figli e nipoti, perché un settore primario sano è fondamentale.
La ricerca medica non può dover essere chiamata ad affrontare anche le conseguenze di un’agricoltura interessata al profitto a spese della salute.
Un cibo prodotto in modo sano e pulito è salute per noi, per tutti gli ecosistemi e per il futuro del pianeta.
Il cibo buono, sano pulito e giustamente remunerato per chi lo produce deve entrare nelle mense scolastiche, negli ospedali, nelle mense aziendali. I bandi di assegnazione non devono più basarsi solo sul contenimento dei costi.
Basta veleni nel cibo, nell’aria, nell’acqua!! Ci vogliono convincere che non sia possibile agire in modo diverso, ma noi sappiamo che non è così!!!
PROGETTO CON LE SCUOLE : ORTO IN CONDOTTA
Abbiamo lavorato molto bene con Istituto Comprensivo di Casteggio e precisamente nel plesso di Borgo Priolo dove, con una classe, abbiamo iniziato un progetto "Orto in Condotta" che si completerà il prossimo anno scolastico.
La mia impostazione è stata:
- preparazione terreno a cura del Comune locale;
- non ho trovato nonni disponibili a seguire il progetto;
- preparazione del terreno per le semine e trapianti fatta con i bambini e i docenti molto collaborativi
- raccolta dei prodotti fatta dai bambini e consegnata a loro da cucinare a casa (non mi è stato permesso fare degustazioni in classe);
- da parte mia, ogni anno, 6/7 incontri in classe, in aggiunta a quelli in orto, su temi ambientali e sul cibo buono pulito e giusto (biodiversità, ecosistemi, approfondimenti su
- importanza del suolo, spreco, cucina del recupero, ricette con prodotti locali ecc..);
- periodicamente incontri con i genitori;
- i bambini hanno lavorato molto con le maestre, aggiornate con gli incontri con Slow Food Educazione, in attività pratiche nelle varie discipline;
PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI : IL GRANO, DAL CAMPO ALLA TAVOLA
Sono state avviate tante collaborazioni con:
- produttori di grani della tradizione nella media collina
- un panificatore di qualità
- agricoltori
- piccoli produttori locali della comunità OltrePoEtico
- la proloco di Borgoratto Mormorolo
- magazzino dei ricordi di Zavattarello
Attività svolte:
- La proloco si è prestata a collaborare nelle varie attività previste, un agricoltore locale ha messo a disposizione un appezzamento di terreno in collina, l'Associazione Grani della Tradizione ha collaborato nel fornire il seme e antiche attrezzature, il panificatore si è reso disponibile per incontri su impasti e panificazione, alcuni piccoli produttori collinari hanno incontrato in bambini per illustrare la loro attività. Come si è articolato il progetto:
- ottobre 2023 semina a spaglio del grano effettuata dei bambini; ciascun bambino con cesto da semina costruito in cartone; 50 bambini per una mattina impegnati a seminare;
- completato lo spargimento del seme si è proceduto alla copertura del seme con erpici rudimentali costituti da fascine secche trascinate per il campo dai bambini;
durante l'anno scolastico io ho provveduto a illustrare ai bambini le varie fasi di crescita del grano (in campo quando il tempo lo permetteva o in classe portando qualche cespo di grano raccolto in campo); - primi di giugno la mietitura con un'antica mietilegatrice, raccolta in covoni caricati sul carro dai bambini e trasporto in cascina;
primi giorni di settembre trebbiatura con antica trebbiatrice; - macina dei semi con macine manuali fornite dal "Magazzino dei ricordi"
- impasto e cottura del pane in forno a legna.
In occasione del Natale 2024 si è colta l'occasione di fare preparare ai bambini "le reginette" una pasta tipica natalizia. Impasto della farina con acqua e uova, tiratura della pasta, taglio ed essicazione (una giornata di lavoro), cosentendo a ogni bambino di portare a casa circa tre etti di pasta buona, pulita e giusta.
Osservazioni:
- Un bel progetto che mi ha consentito di pensare a nuovi approfondimenti del progetto orto: collaborazioni con enti locali e comunità del cibo;
collaborazione con un nutrizionista per approfondire alcuni aspetti di educazione alimentare; coinvolgimento maggiore delle famiglie; - collaborazione con il gestore della mensa e introduzione di pane locale nella mensa scolastica ed eventualmente qualche altro prodotto;
trovare sempre il modo di portare i bambini in campo con le famiglie e fare con queste alcuni incontri di educazione alimentare. - 2025: Quest'anno parto con una classe prima Istituto comprensivo di Broni.
Suggerimenti: Sarebbe bello anche che Slow Food provvedesse ad alcuni gadget e pubblicazioni - adatte a bambini delle scuole elementari.
Proposte della Condotta di Bergamo
Enrico Radicchi, Gruppo di lavoro educazione, Slow Food Lombardia
PREMESSA
Conosciamo benissimo l’importanza del ruolo degli ORTI SLOW FOOD, nell’ambito dei processi di Educazione Alimentare nelle Scuole.
Dal 2022/2023 è stato proposto di convertire gli Orti in Condotta, in ORTI SLOW FOOD, la cui adesione era, ed è tuttora disciplinata, da un nuovo protocollo che riguarda sia gli ORTI esistenti, sia i nuovi ORTI.
Slow Food Lombardia, ha supportato la Sede per procedere alla conversione degli ORTI e all’istituzione di nuovi.
In particolare, tra gli altri, è stato “convertito” ORTO dell’Istituto Comprensivo di Scanzorosciate (BG) e istituito un nuovo ORTO dell’Istituto Comprensivo di Sovere (BG). Quest ultimo, per inciso, è uno dei primi Istituti in Italia ad avere organizzato “La scuola senza Zaino” e a progettare una grande Biblioteca nell’ORTO.
Tornando all’ORTO di Scanzorosciate, la gestione prevede vengano attivate parallelamente due filoni di attività: una “in campo” e l’altra “in aula” con le classi filtro delle Primarie e Secondarie.
Gli incontri “in aula” seguono un format già collaudato, dove la prima parte è dedicata all’analisi critica dell’alimentazione quotidiana dei ragazzi, allo scenario geografico e culturale legato al cibo nel mondo (Terra Madre), mentre la seconda parte è dedicata ai Laboratori del Gusto (formaggi, salumi, cioccolato, olio) dove gli Alunni e Docenti si confrontano con la complessa attività dell’Analisi Sensoriale.
Parallelamente, nell’ambito degli incontri di Educazione Alimentare, abbiano inserito sistematicamente nei Laboratori del Gusto, il Pane di Filiera Locale-Progetto ASPAN, che prevede la semina, coltivazione e distribuzione della farina tipo1, al panificatore locale, che provvede a distribuire il Pane direttamente e giornalmente, nelle Mense Scolastiche.
L'introduzione di un prodotto di filiera nelle mense, come il Pane, non è di per sé solo un prodotto, ma la sua narrazione che gli alunni toccano con mano e nel contempo acquisiscono un maggior rispetto e consapevolezza nel Consumo, nella difesa Ambiente e del Clima e nel contenimento dello Spreco alimentare. Le Filiere “didattiche” riguardano anche il mais, il formaggio e il miele.
Ogni anno circa 270/300 alunni vengono raggiunti da questi interventi.
Negli ultimi anni, insieme ai docenti, abbiamo incontrato più di 2800 alunni e circa 200 famiglie. Alla fine dell’anno, vengono programmati alcuni incontri con genitori e alunni assieme, dove gli alunni giocano un ruolo didattico, inserendosi nella conduzione e presentazione delle caratteristiche dell’Orto, verso famiglie e cittadinanza.
PROPOSTA
Questa impostazione di buone pratiche ha avuto, non solo positivi riconoscimenti da parte della Dirigenza scolastica e Docenti, ma anche dall’Amministrazione/Sindaco/Scanzorosciate:
“Vi ringraziamo di cuore per il prezioso lavoro svolto nell’ambito del Progetto Didattico Slow Food e per l’impegno dimostrato nel promuovere l’Educazione Alimentare nelle nostre scuole. La collaborazione tra scuole, volontari e partner locali è un valore aggiunto per tutta la comunità”.
Penso che il “modello”, così strutturato, possa essere adattato e proposto nell’ambito dei Progetti ORTI SLOW FOOD della Lombardia, soprattutto in quelli partecipati dalle Amministrazioni.
L’adozione di queste buone pratiche ci permette di coinvolgere gli “anelli” generazionali futuri e divulgare i Principi e la Filosofia di Slow Food.
Interventi di Educazione Alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado
- Inserire nel contesto del progetto educativo alimentare:
- la filosofia di Slow Food
- la contrapposizione con Fast Food
- la biodiversità
- agricoltura artigianale/familiare e prodotti di territorio (con il linguaggio appropriato all età degli alunni)
- I Laboratori del Gusto:
Protagonisti dei Laboratori del Gusto saranno i formaggi, l’olio extravergine di oliva, i salumi, il cioccolato, le aromatiche - I processi degustativi, la comparazione, collegamento tra la diversità biologica del territorio e la risposta dei sensi (visivo, tattile, olfattivo, degustativo) a prodotti diversi per territorio, varietà vegetali/animali, metodi di produzione. Questi concetti, parte integrante del laboratorio, verranno discussi durante la fase pratica svolta con i ragazzi.
- Programma Operativo Gli incontri di Educazione Alimentare, comprensivi di didattica e Laboratorio del Gusto, hanno una durata di ca 2h ciascuno e verranno organizzati per i ragazzi interno delle scuole Elementari, Medie e Superiori.
- Collaborazione con SIR. I Laboratori del Gusto, saranno organizzati con la collaborazione operativa di SIR, sponsor ufficiale delle attività.
Progetto “Il pane della nostra terra”
Grazie alla consolidata collaborazione tra l’assessorato all’Istruzione del Comune di Scanzorosciate e l’Istituto Comprensivo di Scanzorosciate è stato possibile studiare un progetto innovativo che ha coinvolto l’Orto Slow Food- Istituto Comprensivo, Condotta Slow Food di Bergamo, la ditta SIR Sistemi Italiani Ristorazione Collettiva srl di Azzano S. Paolo, ASPAN Associazione Panificatori Artigiani della Provincia di Bergamo e, attualmente, il Panificatore il “Forno di Rosciate”.
Destinatari dell’iniziativa sono i bambini iscritti alla mensa delle Primarie dell’Istituto.
Da anni l’attenzione dell’Amministrazione è rivolta alla ricerca dei progetti innovativi e qualificanti di un servizio tanto delicato com’è quello della ristorazione scolastica: i laboratori del gusto, condotti da Slow Food, il servizio nutrizionale della ditta Sir, la presenza del tecnologo alimentare, finalizzato al monitoraggio della qualità del servizio.
Partendo da una sintetica, ma significativa analisi sull’importazione del grano in Italia (il 70% del quantitativo consumato è di importazione estera), si evince la portata del progetto: l’introduzione di un prodotto esito di filiera produttiva locale (coltivazione, distribuzione e lavorazione delle farine, produzione e consumo del pane sul territorio) ha un significato davvero innovativo e profondo, andato oltre il servizio di ristorazione scolastica, raggiungendo le famiglie del Comune di Scanzorosciate.
Gli obiettivi del progetto, nel tempo si sono consolidati verso un consumo consapevole di materie prime e prodotti di qualità, oltre a processi di educazione e culturali. Il panificio il Forno di Rosciate, coinvolto da Aspan, da Slow Food e dalla ditta Sir per il tramite dell’Amministrazione Comunale e dell’Istituto Comprensivo, rientra a pieno titolo nella filosofia del servizio e del progetto che sostiene il km 0. Spiccano alcuni aspetti positivi che il progetto ha sulla comunità di Scanzorosciate: la coltivazione di varietà di grano “nostrano” si propone, a lungo termine, di invertire le percentuali di provenienza del grano, riducendo in modo consistente l’importazione dall’estero, nonché un incentivo per le piccole e medie imprese della provincia coinvolte nel processo della panificazione.
E’ sempre determinante “raccontare” questo progetto, condividerlo per riscoprire la coltura/cultura del grano che si produce nei nostri territori di prossimità e che rispetta ambiente e clima, in quanto non produce CO2, come invece avviene, in grandissime quantità, nel trasporto transoceanico.
Tra gli altri aspetti che hanno particolarmente coinvolto l’Amministrazione, ne spicca uno a cui presta particolare attenzione: lo SPRECO. Il progetto ribattezzato “Pane della nostra terra” per dare massima attenzione al territorio di Scanzorosciate si inquadra nella promozione del km 0 e si prefigge come obiettivo la riscoperta di antichi saperi e sapori; altra ricaduta positiva è stata la riduzione dello spreco del pane nelle mense del 30%: individuando una grammatura ed una dimensione del panino più consone, si contiene l’avanzo del pane a fine servizio.
L’iniziativa, quindi, svolge azioni in difesa dell’ambiente e del clima.
Quale futuro per il Mercati della Terra di Milano?
Slow Food Milano
MdT è un’esperienza importante e consolidata sia in termini di presenza di aziende agricole (una trentina circa) sia in termini di pubblico (1200 frequentatori ogni edizione). La pagina Facebook del Mercato della Terra conta 12.519 like e 12.820 follower. La pagina Instagram 254 post e 1.860 follower.
MdT non è solo un luogo di scambio commerciale, ma un presidio di cultura alimentare, in cui si
- opera per sostenere i piccoli produttori, detentori di saperi e custodi della terra
- per rafforzare le filiere corte e biologiche.
- per educare la cittadinanza a scelte alimentari consapevoli, sostenibili e legate al territorio.
Evoluzione di MdT in questi anni:
- partecipazione crescente di pubblico
- produttori sempre più artefici in prima persona delle iniziative non solo di promozione dei loro prodotti, ma anche degli eventi educativi,
- attrazione di scuole superiori e interazione con università.
Quale futuro possiamo ipotizzare?
A livello politico
- consolidare il ruolo quale asset della Food Policy del Comune di Milano.
- sviluppare partnership stabili tra amministrazione pubblica, produttori, associazioni civiche e cittadini
A livello economico
- essere sempre più un modello di economia circolare in ambito urbano, limitando gli sprechi e valorizzando scarti e biodiversità
- far diventare la partecipazione a MdT un’opportunità redditizia soprattutto per le donne e l’economia locale
A livello culturale
- diventare un soggetto promotore di iniziative ed eventi di educazione alimentare, anche in partnership con altri soggetti della rete Slow Food quali e con università
- promuovere eventi culturali e scambi che valorizzino tradizioni alimentari diverse, contemporanee all’identità locale
In sintesi:
L’esperienza del Mercato della Terra di Milano può rappresentare
- un volano non solo per le attività di Slow Food ma per il contesto in cui è inserito
- la base per sviluppare una rete di mercati diffusa su tutto il territorio metropolitano e regionale un laboratorio avanzato per innescare processi innovativie partecipativi
La Condotta di Martesana
Delegati della Condotta: Leonardo Scaglioni, Davide Cinquanta
La nostra condotta è nata e opera nella parte orientale dell’area metropolitana di Milano, in un territorio che si estende tra i fiumi Lambro e Adda, attraversato dal canale Martesana, da cui la stessa condotta prende il nome. Proprio a questo canale artificiale si legano le radici storico-culturali del territorio. Utilizzato a scopi irrigui, manifatturieri e commerciali, fu progettato dal genio di Leonardo da Vinci. A cavallo tra l’Alta e la Bassa Pianura Padana, interamente pianeggiante, il territorio è delimitato a sud dalla fascia delle risorgive i fontanili e vede la prevalenza di paesaggi planiziali e fluviali. Il settore agro-alimentare è pesantemente influenzato dal forte inurbamento del territorio, che ha avuto inizio dopo la Seconda Guerra Mondiale a seguito del boom economico, dei flussi migratori provenienti da altre regioni italiane e dall’affermarsi della Rivoluzione Verde. L’espansione dell’area urbana di Milano interessa il territorio imponendo profondi mutamenti nella società, nel paesaggio, nelle attività economiche e nelle vocazionalità produttive. Sul confine fra città e campagna, ci confrontiamo con i temi dell’agricoltura urbana e peri-urbana, dell’agricoltura ad alto contenuto tecnologico (vertical farming, precision farming, ecc.) e dell’agricoltura intensiva strettamente legata al comparto della trasformazione su scala industriale. Rispondere alle esigenze di incremento ed efficientamento dovuto al forte aumento demografico e all’urbanizzazione, ha provocato nei decenni una drammatica e inesorabile erosione della biodiversità locale, oltre all’apparentemente inarrestabile consumo di suolo a danno delle superfici agricole. Le produzioni locali che presentano caratteristiche di sostenibilità e tipicità si presentano dunque ridotte e frammentate, ma questo non ferma la nostra determinazione del conseguire il buono, pulito e giusto nella comunità in cui viviamo.
Tra le iniziative che sviluppiamo sul territorio per diffondere questa cultura, ricordiamo il concorso “Infiniti Blu”, rassegna di produttori di formaggi erborinati con specifica sezione dedicata al latte crudo, inserita nella Sagra annuale del Gorgonzola.
La presenza di Slow Food nel nostro territorio è quantomai necessaria; l’associazione deve essere un punto di riferimento forte, portavoce di una cultura condivisa e conosciuta dalla maggior parte della popolazione. La crescita dell’associazione deve avere come obiettivo l’accreditamento nei confronti dei decisori locali, in modo da influenzare le politiche territoriali e portare così cambiamenti tangibili.
Allo stesso tempo Slow Food deve mantenere il suo dialogo consolidato con le realtà del territorio che condividono e mettono in pratica i valori dell’associazione, in particolare produttori, cuochi e trasformatori, fornendo ascolto, assistenza, supporto e opportunità di crescita alle loro attività.
Sempre più risorse dovranno essere dedicate alle attività educative, perché per avviare un cambiamento della società verso la sostenibilità bisogna accrescere la cultura, la responsabilità e il senso critico della popolazione. Progetti scolastici e attività di degustazione devono essere implementati per essere presidi costanti dell’associazione sul territorio, e a tale scopo devono essere accessibili ed efficaci.
Si devono incrementare le occasioni di aggregazione e di ricostruzione delle comunità e del tessuto sociale locale: le città del nostro territorio hanno visto un forte sviluppo urbanistico secondo la modalità delle “città dormitorio”, distruggendo il legame tra abitanti e le comunità, con conseguenti fenomeni di degrado, abbandono, perdita di culture, tradizioni e saperi. In questo ambito andiamo molto fieri dell’orto sociale sorto presso la nostra Condotta, modello da riprodurre e propagare il più possibile.
Slow Food deve imporsi nel dibattito pubblico sostenendo che l’agricoltura tradizionale e quella industriale non devono essere realtà contrapposte, ma il più possibile complementari e integrate a reciproco beneficio, con il comune obiettivo di fornire prodotti alimentari in modo rispettoso e sostenibile per l’umanità e per il pianeta. A questo scopo devono essere allacciati nuovi legami, e consolidati quelli già esistenti, con i luoghi di produzione della conoscenza, con le associazioni di categoria e con gli enti locali. Particolare impegno deve essere speso nella creazione di collaborazioni con l’imprenditoria privata, importante risorsa del nostro territorio, con lo scopo di generare percorsi condivisi, supportati dalle necessarie risorse economiche.
La condotta della Martesana, insieme ad altre sezioni lombarde di Slow Food, spesso patiscono per la loro “scarsa ruralità”, il loro ruolo deve essere invece di primo piano nel panorama italiano di Slow Food. Questi territori possiedono importanti risorse che devono essere sfruttate in sinergia con tutta l’associazione avviando scambi sempre maggiori con le realtà Slow Food di tutto il territorio nazionale.
In particolare, pensiamo al grande capitale umano, agli sbocchi di mercato facilmente accessibili, e alla vicinanza geografica con altri Paesi Europei
Torniamo a essere avanguardia, movimento umanista
Gabriella Chiusano
Essere qui tra le mura della FAO, l'agenzia della Nazioni Unite, mi fa sentire ancora di più parte di un sogno globale: un futuro dove ogni persona ha accesso al cibo nutriente e abbia garantita la dignità del suo popolo. Un obiettivo che dovrebbe essere ovvio, se non superfluo, se al centro delle logiche che muovono il mondo, ci fossero L'UOMO e l'ecosistema in cui vive.
Noi siamo qui chiamati in questa sede a riflettere sul futuro della nostra associazione, sui suoi organi e sul modo in cui vogliamo che funzioni, lo facciamo nel rispetto dei principi democratici che ci guidano e lo facciamo dandolo per scontato, in un momento storico in cui anche i principi democratici sono minacciati.
Siamo qui chiamati a difendere questa idea di mondo che abbiamo già da 40 anni, che abbiamo sempre voluto, anche quando dirlo e pensarlo sembrava a tratti un po' folle. Sono entrata in Slow Food quando era considerata da tutti un'avanguardia nella lotta per le tutela dell'ambiente e della biodiversità, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che valorizza la cultura gastronomica locale rispettosa dell'ambiente e del mondo. Slow Food ha dato voce ai produttori agricoli e dei consumatori, lavorando incessantemente per difendere i loro diritti. Oggi Slow Food è riconosciuta come una delle principali organizzazioni a livello mondiale nella promozione di questo modello di sviluppo sostenibile.
Negli ultimi anni ho avvertito però una crescente difficoltà a mantenere questa posizione di avanguardia e di guida nei progetti di tutela, in più le cose da tutelare sono aumentate, e corriamo il forte rischio di diventare più un avamposto di difesa che un'avanguardia.
Quello che sento di chiedere a questa Assemblea, al nuovo comitato esecutivo e a noi tutti è di non accontentarci e relegarci a ruolo di avamposto, di nicchia che crede, sogna e spera in un mondo migliore, ma che rischia di restare una chimera perché spesso assorbiti da dinamiche organizzative, ma di riportare l'impegno quotidiano attivo nell'essere ancora e di nuovo un'avanguardia che può guidare un movimento UMANISTA che mette al centro non solo il cibo e la sua tutela, ma anche e soprattutto l'uomo. Mai come ora abbiamo bisogno di volare alto e ripensare davvero ad un mondo nuovo, un mondo che si basi su modelli economici rigenerativi e non distruttivi.
A Scuola di Gusto e Responsabilità, la Mensa come Palestra di Cittadinanza
Antonio Ciappi, Slow Food Toscana
Ancora oggi in Italia non tutti gli studenti delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie sono in grado di poter esercitare il diritto di gustare e valorizzare in maniera responsabile un buon piatto di pasta al ragù di lenticchie come si fa imparando e scoprendo la magia del saper leggere e scrivere, basi fondamentali per diventare i cittadini del domani.
Tuttavia, 2 milioni di bambini al giorno usufruiscono di questo Servizio Essenziale, quale è la Refezione Scolastica utilizzando ingredienti biologici, ma anche convenzionali e processati per circa 1000 Tonnellate al giorno, comprensivo di pane e Frutta.
Di queste, circa 400 tonnellate al giorno vengono scartate come cibo avanzato dai piatti dei bambini, i quali attraverso il loro parziale rifiuto, chiedono a noi adulti di condividere la responsabilità di educarli al gusto, di utilizzare nella preparazione dei cibi ingredienti sani, freschi, naturali, possibilmente biologici, non processati, provenienti da allevamenti estensivi e metodi di pesca sostenibile.
I concetti di BUONO, PULITO e GIUSTO contenuti nelle Buona Legge dei CRITERI MINIMI AMBIENTALI in vigore e obbligatoria da applicare nei Bandi e Gare per gli Enti Pubblici dal 2020. Con un piccolo problema (tipico del nostro Paese) che non sono stati previsti i controlli e le sanzioni per quel Comuni, Enti che non la applicano nel proprio Appalto. L'ultimo Report di Foodinsider sull'andamento qualitativo della Ristorazione Scolastica Italiana dimostra che quei Comuni, indipendentemente dalla posizione politica che esprimono, che hanno applicato questa Legge, alla cui stesura ha collaborato anche Slow Food, si distinguono per la qualità del loro servizio, come ad esempio il Comune di Sesto Fiorentino che, attraverso l'ottima gestione della propria Società in house Qualità e Servizi è stato premiato per l'anno 2024 come miglior Comune d'Italia.
Comunicare, per mezzo di un Menù parlante, che evidenzi il valore degli ingredienti utilizzati (Biologici, DOCG,DOP, locali, di allevamenti estensivi, Antibiotic-Free, Locali, da Pesca Sostenibile, ecc. ) alle famiglie con trasparenza il valore delle ricette proposte giornalmente per responsabilizzare I genitori e di seguito gli insegnanti a preparare i bambini all'assaggio e al piacere del Gusto dei piatti proposti giorno per giorno. Formare i cuochi e gli addetti mensa alla valorizzazione del cibo preparato e servito nei piatti dei bambini, coinvolgendoli e facendo loro conoscere la qualità degli ingredienti, la cura nell'esecuzione delle ricette e della fase di distribuzione, facendogli ritrovare l'orgoglio e il piacere della propria professione. Non più riscaldatori di cibi processati o di cattiva qualità, ma attori protagonisti di un Servizio basato sui principi della Sostenibilità.
- Monitoraggio degli scarti dei pasti come fulcro di un processo costante di miglioramento continuo della Qualità con una raccolta dei dati qualitativi e quantitativi che sta alla base di qualsiasi progetto di Economia Circolare.
L'analisi delle cause degli scarti (siano esse dovute agli ingredienti, gastronomiche, di errato accoppiamento delle ricette, di mancato supporto del corpo insegnante, di carenze oggettive (poco tempo, refettori rumorosi e caotici) di mancata preparazione dei bambini alla conoscenza del menù) porta alla individuazione dei correttivi da intraprendere in maniera condivisa tra i vari stakeholders creando le premesse per la formazione di una vera e propria Comunità del cibo.
Su questo lavoro costante si possono individuare i percorsi mirati di EDUCAZIONE ALIMENTARE, tanto importante per Slow Food, finalizzati alla soluzione dei problemi evidenziati e con il fine di diminuire gli scarti e far crescere la consapevolezza dei bambini del valore del CIBO.
Come Associazione dobbiamo quindi difendere questa Legge dal ripetuto tentativo di cambiamento o peggio di annullamento invocato continuamente dalle grandi aziende di Ristorazione Collettiva, fare pressione sui Comuni del proprio territorio perché venga applicata integralmente e chiedere al Governo che, diminuiti gli stanziamenti economici sul Biologico, dirotti contributi economici per quei Comuni che da anni la applicano.
NON LASCIAMO SOLI E IMPREPARATI I BAMBINI NEL MOMENTO DI CONFRONTO CON IL CIBO. PREPARIAMOLI AL PIACERE DEL GUSTO E ALLA RESPONSABILITÀ DI DIVENTARE CONSUMATORI CONSAPEVOLI OGGI E CITTADINI DEL DOMANI.
L’Assemblea Nazionale di Slow Food Italia per l’arresto del consumo di suolo
Loredana Pietroniro
Anche quest’anno nella nostra Assemblea torniamo a parlare del consumo di suolo e della necessità di una legge che ne favorisca l’arresto. Ce lo impongono i dati: nell’ultimo anno – si legge nel rapporto ISPRA - le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 72,5 km2, ovvero, in media, circa 20 ettari al giorno. Un incremento del suolo consumato che, seppur inferiore rispetto allo scorso, si conferma al di sopra della media dell’ultimo decennio (2012-2022), pari a 68,7 km2 annuali.
Nel 2024 il nostro Paese ha perso suolo al ritmo di 2,3 metri quadrati ogni secondo. Un grande impatto sul territorio nazionale stanno avendo gli impianti fotovoltaici a terra, la logistica e la grande distribuzione. Ma sul suolo agricolo, questa preziosa risorsa, incombe anche lo spettro delle cosiddette “grandi opere”: per questo chiediamo di riprendere il filo della mozione approvata a Genova nel 2021, Proteggere il suolo per tutelare gli ecosistemi[1] dal momento che ancora non c’è una legge per l’arresto del consumo di suolo. Nell’attuale scenario in cui si susseguono grandi eventi internazionali le cui opere preparatorie infliggono pesanti danni agli ecosistemi naturali, l’impegno della rete Slow Food Italia è essenziale. E allora pensiamo e agiamo come comunità: “la parola mescolanza ci ha educato e ci ha mostrato che i confini regionali o nazionali non esistono, le risorse sono un bene comune e se siamo insieme ognuno ne trarrà beneficio”.
Esistono tantissime vertenze aperte dalla società civile in difesa del suolo e degli ecosistemi in tutto in territorio nazionale, da Catania a Maranello, dalle Langhe fino qui a Roma, dove sono iniziati gli espropri per costruire un nuovo stadio ignorando l’esistenza del bosco di Pietralata, importantissimo per la mitigazione del clima di quel settore della città e per la costruzione dell’autostrada Roma Latina il cui tracciato costituisce una minaccia per la riserva naturale di Decima Malefede quando da anni si chiede la messa in sicurezza della Pontina e la costruzione di una metropolitana leggera.
Chiediamo che Slow Food Italia sostenga la campagna nazionale per suggerire a tutte le amministrazioni comunali italiane la possibilità di utilizzare uno strumento normativo in grado di fronteggiare il fenomeno degli immobili abbandonati nel proprio territorio e, allo stesso tempo, incidere su una situazione che vede quasi un terzo degli edifici esistenti in Italia in condizione di inutilizzo o degrado, a fronte di Piani urbanistici che prevedono nuove edificazioni e, dunque, nuovo consumo di suolo promossa dal Forum Salviamo il Paesaggio.
Infine chiediamo alla nostra rete di fare il possibile per far conoscere i costi in termini di perdita di servizi ecosistemici del consumo di suolo utilizzando il lavoro del lavoro del Gruppo di studio del Forum basato sugli ettari di suolo naturale perduto negli ultimi sedici anni (cioè quanto cemento e asfalto hanno sostituito la “terra” naturale), la percentuale di superficie comunale impermeabilizzata (cioè l’avvenuta “antropizzazione”), il costo annuale in migliaia di euro derivante dalla perdita della risorsa suolo per ciascun Comune e il debito complessivo da ciascuno accumulato.
Dobbiamo tornare sui territori
Luisa Peris
L’assemblea è un momento importante. Un tempo collettivo di scelta, ma anche di confronto vero: su dove siamo, su dove stiamo andando e su cosa siamo diventati.
Un momento in cui misurare la coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo.
Viviamo in un mondo che cambia a una velocità impressionante, per questo credo che un appuntamento ogni quattro anni non basti. Abbiamo bisogno di strumenti leggeri, condivisi e continui, che ci aiutino a valutare il nostro agire in itinere, non per controllare, ma per capire, correggere, rafforzare.
Un accompagnamento dell’azione, pensato con la rete, che ci permetta di fare meglio ciò che vogliamo fare.
- Buono, pulito e giusto: o è per tutti, o non è
Il nostro motto è potente e necessario, ma se non lo decliniamo nella realtà, rischia di restare un’affermazione di principio.
“Buono, pulito e giusto per tutti” significa che o è davvero per tutti, oppure non è.
Non può essere solo per chi se lo può permettere, mentre milioni di persone non hanno nemmeno accesso a un pasto decente.
Questa è la frattura politica e culturale su cui dobbiamo concentrare la nostra azione.
Se non mettiamo questo “per tutti” al centro, non stiamo facendo giustizia alimentare.
Questa è una sfida politica, etica e concreta. E su questo dobbiamo misurare la nostra incisività.
- La rete: essere, non solo dirsi
Essere una rete non significa soltanto avere strutture, ma agire in connessione, sostenersi a vicenda, circolare informazioni, conoscenze, esperienze.
Molte delle risorse e delle proposte di Slow Food esistono già: penso all’Accademia Popolare del Gusto, che potrebbe essere un potente strumento di educazione al consumo consapevole, valorizzando gli artigiani del gusto territoriali, formatori, competenze diverse.
Eppure in pochissime realtà è stata attivata.
Il problema non è solo informativo, ma di formazione dei dirigenti, perché possano attivare questi strumenti, utilizzarli, farli vivere nei territori.
La rete è fatta di nodi-persona, e ognuno può diventare portatore di cambiamento, cultura, consapevolezza. Ma serve sostegno, strumenti, dialogo, occasioni di confronto.
- Educazione: la mia storia, il nostro futuro
Parlo di educazione anche perché è il mio ambito, è la mia storia in Slow Food.
Per decenni, Prato è stata il centro nazionale della formazione di Slow Food, e io ne sono stata direttrice e docente.
Allora, pochissime – se non rare – sono state le regioni che non hanno attivato almeno un corso di formazione per i docenti.
La capillarità è stata massima, anche grazie alla sinergia con l’Ufficio Educazione di Bra.
Quel sistema ha funzionato. Poi è stato naturalmente superato dall’arrivo dell’Università, ma credo che oggi possiamo riprenderne lo spirito.
Oggi abbiamo bisogno di una formazione permanente, diffusa, che sostenga chi fa educazione, chi presiede, chi anima le comunità.
Non è vero che gli educatori sono “lasciati soli”: si sentono soli.
E se alcune delle proposte educative che ho citato già esistono, forse non sono abbastanza conosciute, accessibili, supportate.
Dovremmo allora potenziare l’informazione già puntuale che Slow Food diffonde, ma che forse non arriva dove vorremmo.
In questo, la rete può fare moltissimo, se la pensiamo come una rete viva e attiva, fatta di nodi-persona.
- Giovani: diritto di cittadinanza
Non basta dire “coinvolgiamo i giovani”.
Serve dar loro spazio, delega, fiducia.
Nella mia Condotta, che ho presieduto per un mandato e mezzo, abbiamo lavorato affinché nel nuovo gruppo dirigente ci fosse un vero rinnovamento: oggi il vicepresidente di Slow Food Prato ha meno di 30 anni.
Non è una scelta simbolica, ma una scelta politica.
I giovani non sono il futuro. Sono il presente. E senza di loro non ci sarà futuro.
- Giustizia territoriale: dalle Terre Alte alle città
Dobbiamo smettere di parlare di “aree marginali”.
Le Terre Alte, le aree interne, sono la maggior parte del nostro Paese.
Custodiscono acqua, aria pulita, biodiversità, saperi, relazioni, cultura.
Chi resta in quei territori lo fa con fatica, ma anche con energia, idee, visione.
Slow Food deve stare accanto a queste persone, non solo con eventi, ma con presenza e strategie.
Allo stesso tempo, le città sono il nostro banco di prova: luoghi in cui il legame con il cibo è spesso perduto, ma dove si può ricostruire.
Attraverso politiche del cibo, mercati contadini, orti urbani, refezione scolastica, si può cambiare il modo in cui milioni di persone si nutrono, pensano, vivono.
Due contesti diversi, una sola idea di giustizia territoriale.
- Agroecologia: la nostra idea di giustizia agricola
L’agroecologia non è solo una pratica agricola, è una visione politica.
Una visione che mette insieme diritti dei contadini, cura dell’ambiente, rigenerazione dei suoli, rispetto degli animali e dei cicli naturali.
L’agroecologia è la risposta concreta alla crisi climatica e alla crisi della produzione agricola.
È il nostro modo per dire che un altro modello agricolo è possibile, necessario e urgente.
E Slow Food deve continuare a sostenerlo con forza, nelle politiche, nellaformazione, nei progetti, negli eventi.
- Alleanze, eventi, potere collettivo: senza formazione non c’è rete
Slow Food è un soggetto politico, culturale, sociale.
Lo è nella misura in cui è dentro le battaglie per i beni comuni, contro le disuguaglianze, contro la standardizzazione, per i diritti dei lavoratori del cibo, per chi ogni giorno resiste nei campi, nei pascoli, nei mercati.
Le alleanze con altri soggetti, istituzioni, organizzazioni sono fondamentali, ma hanno senso solo se la rete è pronta.
Senza formazione, non c’è attivismo.
E senza attivismo diffuso, gli eventi restano grandi contenitori, ma vuoti.
Dobbiamo tornare a pensare formazione, comunicazione e mobilitazione come tre dimensioni integrate.
Conclusione
Slow Food ha cambiato la cultura alimentare del nostro Paese e non solo.
Ha insegnato a milioni di persone a guardare il cibo come atto agricolo, ambientale, politico.
Ma oggi, per non perdere la nostra forza, dobbiamo tornare radicati nei territori, capaci di educare, formare, ascoltare, includere.
Dobbiamo tornare ad avere cura della rete, delle persone, delle connessioni vere.
Io credo ancora profondamente in questo progetto.
Credo nella sua capacità di rigenerarsi, senza perdere radici né orizzonte.
E credo che ogni persona in questa rete possa essere portatrice di cambiamento.
Grazie per l’ascolto. Buon lavoro a tutte e tutti.
Come accogliere le nuove generazioni
Roberto Giordano, Vice Presidente Slow Food Nord Milano
Buongiorno a tutti
Sento echeggiare su questa assise, domande importanti… “dove sono i giovani?”.. “cosa fanno i giovani?”… “come intercettiamo i giovani?”…
Domande importanti dicevo, a cui cercherò di rispondere con un paio di esempi di comportamento, nel caso un giovane venga a bussare la vostra porta. Gli esempi sono mirati nel caso siate una piccola condotta di provincia, il secondo di una grande città.
Nel farlo prenderò ad esempio una delle mie due figlie, Gea, 22 anni. Vedete, a casa mia abbiamo una scala di accesso in ferro e Gea calza prevalentemente anfibi. Il terrore si legge sui
nostri volti, quando sentiamo battere sui gradini… “bum, bum, bum!” spalancarsi rumorosamente la porta e apparire una testa che dice: “Avrei una domanda..” oppure “avrei una proposta”...
Ora mettete che alla porta della vostra piccola condotta di provincia appaia veramente Gea dicendo: “ho una domanda… mettiamo che voglia formare un’associazione che si occupi di cibo, ma mica una cosa tipo le confraternite, un’associazione che abbia una succursale in tutte le nazioni, una roba moderna insomma”… “ ma Gea, sei matta? Ti rendi conto di quello che
dici? Manco fossimo in una grande città… queste cose si possono fare a Parigi, Londra, New York, noi non abbiamo capacità né esperienza”.. “Ma no papà… a parte che qui è un posto bellissimo per questo tipo di cose, noi gli mettiamo un bel nome inglese, che fa tanto Milano, poi con un po' di austera anarchia sistemiamo le cose”. Austera….pensa se era opulenta…
Voi cosa avreste risposto?
Secondo esempio: “ papà, ho avuto una bellissima idea… mettiamo che portiamo in città qualche migliaio di contadini e allevatori, ma mica quelli sui trattori. Io voglio gli esquimesi, i masai, i nativi americani e facciamo con loro una grande assemblea per il nostro pianeta.
Altrimenti, cosa mi hai chiamato Gea a fare?”… “Gea, non ti rendi conto… a parte i soldi, ma hai idea dei visti, dei permessi di soggiorno, degli alloggi che servono? Questi manco hanno la
carta di identità e molti di loro non avranno mai preso un aereo in vita loro.”… “ma non preoccuparti papà… vedrai, con un po' di intelligenza aƯettiva sistemiamo le cose”…
Voi cosa avreste risposto?
Tornando seri, a me sembra che noi stiamo vivendo una crisi di crescita. L’ossatura di questa associazione è fatta da persone che hanno avuto Slow Food come punto di arrivo, un naturale punto di arrivo. Abbiamo fatto tante cose insieme, piccole e grandi.
Adesso che arriviamo ai nostri primi quarant’anni, come Marina Ripa di Meana, forse anche noi dovremmo scrivere un libro di storie, ma fatto come l’atlante dei presidi, perché ognuno di noi è un presidio di storie. Il problema è che adesso sta arrivando la generazione dei nativi Slow Food… per loro siamo un punto di partenza.
A volte, con loro diventiamo esigenti, a volte troppo esigenti. Certo, accompagnare, spiegare, consigliare, è obbligo e necessità. Ma non facciamo mai l’errore di mettere davanti la nostra storia alla loro.
Autorevoli studi internazionali, hanno scientificamente dimostrato che i giovani sanno benissimo sbagliare da soli, non hanno bisogno di aiuto in questo.
Per concludere il mio intervento, vorrei dire anche due parole rispetto alla necessità che ho rilevato in qualche intervento, di campagne pubblicitarie per far conoscere l’associazione. Io
avrei lo slogan, parafrasando una vecchia frase che girava negli uƯici tanti anni fa:
“SLOW FOOD – MIRACOLI NE FACCIAMO, L’IMPOSSIBILE CERCHIAMO DI FARLO, PER LE COSE NORMALI CI STIAMO ORGANIZZANDO”
I 12 punti per l’agricoltura artigiana
Giannozzo Pucci
Il libro “Liberare la terra dalle macchine” (Atelier Paysan, Libreria Editrice Fiorentina, 2223) dimostra che l’agricoltura industriale non è agricoltura ma occupazione industriale dei campi con gli avvelenamenti, le dipendenze commerciali, bancarie, burocratiche, digitali, i danni alla salute e alla qualità del cibo tipici dell'industria.
L’agricoltura è artigiana ed ecologica, il movimento dell’agricoltura artigiana serve a costruire una strategia, che è uno spazio politico, tecnico, economico di conversione ecologica del territorio che tende a diffondersi in delle pratiche nuove virtualmente aperte a quasi tutti gli ambiti non solo agricoli.
Invece i movimenti di opposizione… al nucleare, agli inceneritori, ecc. si oppongono a obbiettivi politici di altri, non costruiscono una conversione a pratiche ecologiche in positivo miranti a liberare il territorio da tutti gli inquinamenti per costruire un’economia e una società totalmente in sintonia con la natura, secondo quanto indicato dalla Laudato sì.
Senza sciogliere i lacci che impediscono e penalizzano l’agricoltura artigiana, è pura illusione credere che si possano difendere le piccole aziende agricole. Occorre costruire un movimento di agricoltori artigiani liberi di occupare i territori abbandonati e che le industrie, con le loro macchine e monocolture, non sono tecnicamente e mentalmente in grado di gestire.
Occorre sviluppare questo spazio economico, tecnico, politico, nuovo che può diventare vero movimento ecologista, coinvolgendo le associazioni, i comitati anti inquinamento, verso ogni forma di coltivazione senza veleni tramite alcuni obbiettivi straordinari comuni su cui convergere unanimi.
Dal momento della secca del Po è cominciata in Italia un’altra Era, nella quale non è ammesso che ogni associazione ambientalista si faccia solo i fatti suoi, ma pur continuando a farli, è moralmente necessario che tutte si impegnino a scoprire alcuni obbiettivi completamente comuni e identici per moltiplicare le forze. Poiché senza moltiplicare centinaia di migliaia di volte la presenza di persone impegnate materialmente nella natura, nella campagna, nella produzione del cibo sano e nel territorio, non è possibile una conversione ecologica, propongo di riflettere sui seguenti obbiettivi per arrivare a maturare motivazioni forti e approfondite di un nuovo movimento di conversione ecologica radicale:
- 1 Dicesi agricoltura artigiana l’insieme di attività non imprenditoriali di cura e manutenzione del territorio tramite piante e animali con conseguenti produzioni alimentari senza uso di pesticidi e con la massima diversità di colture.
- 2 La coltivazione manuale e artigiana senza pesticidi a qualsiasi titolo di un terreno è certificazione in sé che supera qualsiasi certificazione urbanistica o di altro genere e costituisce titolo per far parte di un elenco speciale artigiano, indipendentemente dal numero di ore di lavoro;
- 3 Dall’assenza di scopi speculativi discende che la nuova agricoltura artigiana è esente dall'obbligo di iscriversi alla camera di commercio e all’IVA, perché come per i secoli passati è sottoposta al regime di esenzione dall’attività commerciale non comprando, ma producendo, per vendere
- 4 La cura artigiana del territorio è un servizio pubblico e come tale oggetto di attività di volontariato coperto da assicurazione a carico pubblico;
- 5 L’agricoltura artigiana non ha obblighi di corsi di formazione basandosi sull’apprendistato e sul volontariato;
-6 All’agricoltura artigiana non sono necessarie autorizzazioni ambientali non producendo inquinamenti;
-7 Tutti gli enti e uffici amministrativi con competenze agricole per quanto riguarda l’agricoltura artigiana passano dal comune;
- 8 L’istituzione di un salario di contadinanza per chi intraprende un’attività di nuova agricoltura artigiana dopo periodi congrui di apprendistato e volontariato come studenti, è una politica economica essenziale per la fertilità e l’economia del territorio;
- 9 Occorre formare un nuovo catasto agricolo comprendente i terreni utilizzati in agricoltura artigiana agro-ecologica che non potranno essere urbanizzati;
- 10 Gli artigiani agro-ecologici hanno diritto all’analfabetismo burocratico e digitale. Tutte le pratiche col pubblico saranno a carico pubblico, con funzionari itineranti, incaricati di completarle senza lavoro-ombra a carico dell’artigiano agricoltore.
- 11 Gli artigiani agro ecologici potranno sperimentare nuove forme di collaborazione associativa e di apprendistato coi proprietari o possessori a qualsiasi titolo dei terreni.
- 12 Gli immigrati con competenze manuali nei campi artigiani in generale, agricoli, edilizi ecc. potranno ricevere un permesso di soggiorno da studente per apprendere competenze ecologiche aiutando in Italia a costruire, in territori abbandonati o semi abbandonati, un’economia totalmente ecologica.
Cibo e conflitto: coltivare relazioni, nutrire la pace
Maria Ricci
Associazione Rondine Cittadella della Pace
Il cibo e il conflitto, apparentemente distanti, sono oggi più che mai strettamente intrecciati. I conflitti armati non si combattono solo con le armi: si combattono anche con il controllo delle
risorse, dell’acqua, del grano.
Pensiamo al caso dell’Ucraina. La guerra ha bloccato o rallentato l’export di cereali, facendo salire i prezzi sui mercati internazionali e mettendo in crisi interi sistemi alimentari in Africa e Medio Oriente. Paesi come la Somalia, il Sudan o il Libano dipendono in larga parte dal grano ucraino o russo: quando quel grano non arriva, la carestia si avvicina, e con essa nuove tensioni, nuove guerre.
Il cibo non è mai neutro: può essere causa di conflitto, ma anche chiave di riconciliazione. E proprio da questa consapevolezza nasce un terreno fertile per l’incontro tra due realtà
apparentemente diverse ma potenzialmente complementari: Rondine Cittadella della Pace e Slow Food.
Rondine, per chi non la conoscesse, è un’organizzazione italiana che da oltre vent’anni lavora per la trasformazione creativa dei conflitti. Nella sua Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo, accoglie giovani provenienti da paesi in guerra – ucraini e russi, israeliani e palestinesi, armeni e azerbaigiani – e li fa vivere insieme, studiare insieme, conoscersi. Il “nemico” diventa volto, storia, essere umano. Il conflitto non viene rimosso, ma attraversato, dunque trasformato.
Slow Food, invece, ci insegna che il cibo è cultura, identità, biodiversità. Che nutrirsi non è solo sopravvivere, ma scegliere un modo di stare al mondo. Un modo rispettoso delle persone, dei territori, delle comunità.
Allora, immaginiamo cosa potrebbe nascere da un incontro tra queste due visioni. Immaginiamo giovani di Rondine che, oltre a convivere, coltivano insieme un orto. Che si raccontano attraverso le loro ricette. Che riscoprono semi antichi delle rispettive terre. Che cucinano insieme, mangiano insieme, e mentre lo fanno, imparano a fidarsi.
Immaginiamo percorsi educativi congiunti, dove si intrecciano la cura della terra e la cura della relazione. Progetti di agricoltura comunitaria nei territori post-conflitto. Racconti di pace scritti attorno a una tavola. Piccole comunità dove il gusto diventa veicolo di riconciliazione.
Perché il cibo, come la pace, ha bisogno di tempo, di mani, di ascolto. Non si impone, si coltiva.
E in un mondo in cui la guerra semina fame e disumanità, il gesto semplice del cucinare insieme può diventare rivoluzionario. Può insegnarci che, anche nei conflitti più duri, esiste un terreno comune: quello del bisogno, dell’identità, della memoria, del pane.
E su quel terreno possiamo tornare a costruire. Con pazienza. Con visione. Con la forza gentile delle relazioni.
Condividete sui social le vostre immagini dell'Assemblea!
Raccontiamo, tutti insieme, Un’altra idea di mondo
Potete taggare:
@italia.slowfood su Facebook
@slow_food_italia su Instagram
Potete usare l'hashtag
#slowfooditalia, che contraddistingue la nostra comunicazione
Nei locali della FAO che ospitano l’Assemblea diversi pannelli con la grafica slow che potranno fare da sfondo alle vostre fotografie.
Saranno inoltre effettuate riprese fotografiche e video dagli operatori ufficiali.
La partecipazione all’Assemblea implica il consenso alla possibile pubblicazione del materiale raccolto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
Comunicati stampa
- I comunicati stampa
- 11 luglio Un’Altra Idea di Mondo: Assemblea Nazionale dei soci di Slow Food Italia
- 11 luglio La cartella stampa
- 11 luglio Barbara Nappini apre l’assemblea dei soci di Slow Food Italia
- 12 luglio Slow Food Italia: Un’altra idea di mondo è la felicità dell’immateriale, l’ottimismo dei giovani, la gioia della partecipazione democratica e il piacere di agire dal basso per cambiare il mondo
- Le foto della plenaria
- La playlist con tutti gli interventi della plenaria
- Il video ufficiale dell'Assemblea
Video Istituzionale
Noleggio auto
Se per i vostri spostamenti state pensando alle quattro ruote, potete rivolgervi a Maggiore Autonoleggio, partner dell’Assemblea, che offre a tutti i delegati la possibilità di accedere direttamente al secondo livello del Maggiore Club, senza alcun costo d’iscrizione, usufruendo fin da subito del 15% di sconto sul noleggio auto, la seconda guida gratuita e la seconda guida giovani inclusa.
Iscriviti subito.
Inoltre, per la vostra attività professionale di ogni giorno, AmicoBlu, leader in Italia nel noleggio di furgoni a breve e medio termine, offre la possibilità di usufruire di uno sconto immediato del 15%.
Prenota subito.
Entrambe le offerte sono valide fino al 31 dicembre 2025
